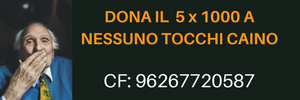07 Maggio 2022 :
Alla fine di marzo è “evaso” dal carcere di Opera un altro detenuto, morto di – come si dice – “morte naturale”. Ma nessuna morte in galera può essere detta “naturale”. Alfio Laudani aveva settantasei anni ed era gravemente malato. Stava scontando diverse condanne all’ergastolo e ogni mese partecipava in stampelle al laboratorio di Nessuno tocchi Caino. All’ultimo, a metà aprile, non si è presentato. I suoi compagni detenuti lo hanno commemorato con parole commosse che riecheggiano in questo scritto.
Giuseppe Grassonelli*
Quando Virginia Woolf scrisse Al faro, aveva in mente un’elegia che portasse con sé il sapore della vita che si perde. Dopo trent’anni di carcere, io sono giunto alla conclusione che noi tutti riusciamo davvero a raccontare solo quello che perdiamo, affidando alla parola il tentativo di trattenere il tempo. Si tratta di un tentativo disperato, affermerebbe qualcuno, ma noi siamo Spes contra spem e con questo nome, sotto l’egida di Nessuno tocchi Caino, ci incontriamo da anni nel Carcere di Opera. Ci narriamo di un tempo che non ci appartiene più, un passato dal quale ci siamo emancipati, e a questo sovrapponiamo i decenni di reclusione, tirando le somme con i giorni appena trascorsi.
L’ultimo laboratorio si è aperto con la commemorazione di un nostro caro compagno, venuto a mancare a marzo. Sergio D’Elia, il nostro Segretario, ha aperto le riflessioni dicendo che il cuore si ferma quando non c’è l’amore, perché non gli è concesso di amare ed essere amato. Si può, infatti, essere vivi solo nel rapporto con l’altro e ognuno è delegato a rappresentare la vita solo nella misura in cui ama ed è riamato. In altre parole, l’unica obiezione che possiamo muovere al tempo che se ne va è l’amore, che è come un calco capace di imprimere con il ricordo una pergamena che scorre inesorabile.
Il nostro racconto si allunga dei giorni trascorsi e con essi cresce il numero dei compagni che in carcere hanno perso la vita e che vogliamo ricordare. Ciò che più ci rattrista è che in noi sia subentrata una certa abitudine alla morte, consapevoli di abitare in un cimitero vivente, pronti alla bisogna, sapendo che domani l’ennesimo sacco nero accompagnato da sguardi vuoti attraverserà il corridoio della sezione, portando via nel silenzio assordante un altro detenuto. Noi non abbiamo nulla e siamo privati anche del possesso del tempo: non possiamo fare programmi per domani, non sappiamo quando ci sarà una lezione o un laboratorio, gli incontri li sappiamo quando accadono. Viviamo in regime di completa espropriazione del tempo, eppure abbiamo una certezza: domani il sepolcreto tornerà ad animarsi della morte e la sua porta si spalancherà per un’altra vittima.
A ogni gesto, la prigione recita al detenuto il suo memento mori con la negazione degli utensili più banali, con l’impossibilità di una vita affettiva e sentimentale, col divieto di umanità. È un’impresa sbucciare una mela o trovare una superficie che rifletta per radersi senza tagliarsi con un rasoio in momentanea concessione. In carcere non ci si specchia in nessun modo. La filosofia mi ha insegnato che noi ci specchiamo negli amici e negli affetti, attraverso quelle relazioni di cui parlava Sergio. L’immagine che di noi vediamo nell’altro, diverso da noi, ci consente di evadere dalla prigione del nostro essere. «Non siamo forse tutti prigionieri?», diceva Virginia Woolf attraverso Mrs Dalloway. Sì, siamo tutti prigionieri – rispondo io – ed è per questo che abbiamo un vitale bisogno di amare, ma in carcere un detenuto può solo guardarsi negli occhi di un altro uomo recluso come lui e lì trovare il riflesso della sua stessa prigionia: viviamo in una bara. Dall
a parte opposta, si dice che la giustizia debba preservarsi dalle emozioni e dai sentimenti, essere asettica e razionale come una scienza. Ma – vi domando – come può dirsi giusta una giustizia che disconoscendo la pietas si veste della freddezza che nel linguaggio quotidiano si attribuisce agli omicidi?
Portare testimonianza sulle morti dei compagni detenuti è un nostro dovere morale, lo abbiamo sempre fatto nel modo migliore che ci era dato e non avremmo potuto non farlo. Noi detenuti siamo i superstiti, i testimoni di una conoscenza di cui siamo diventati consapevoli a poco a poco. Siamo una minoranza insolita e minuscola, quelli che per capacità o per una strana sorte sono ancora vivi perché non hanno raggiunto il fondo o forse, banalmente, perché siamo stati arrestati giovanissimi. Dice un verso di Cristina Campo che «non si può nascere ma si può restare innocenti». Quei ragazzi criminali arrestati trent’anni fa hanno appreso che colpevoli si può diventare, ma qualche verso dopo Cristina scrive: «Non si può nascere ma si può morire innocenti». Ecco noi non sappiamo ancora credere che la colpa si possa perdere e si possa morire innocenti.
* Ergastolano detenuto a Opera