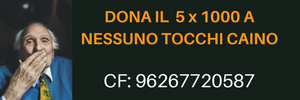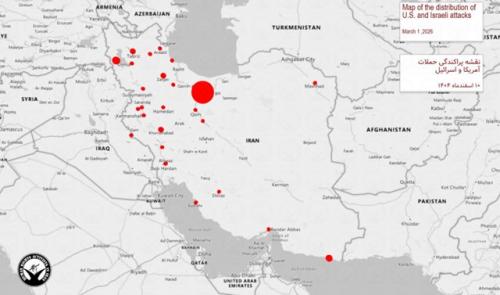17 Aprile 2021 :
Elisabetta Zamparutti su Il Riformista del 16 aprile 2021
Siamo abituati a pensare al monumento come ad una costruzione materiale, un edificio o un’opera d’arte. Penso invece che monumento sia tutto ciò che già esiste quando ha in sé la forza di evocare il passato, farci comprendere il presente e aprirci al futuro. Trovo allora esemplare l’idea del Ministro dell’Interno e dell’Eredità Culturale dello Zimbabwe, Cde Kazembe Kazembe, di considerare l’albero di Bulawayo, che i coloni bianchi usavano per impiccare gli africani, monumento nazionale. Questo albero si trova all’incrocio tra la First Avenue e la Masotsha Ndlovu, in quella che è la seconda città per importanza dopo la capitale Harare.
Il restyling cittadino che è arrivato fin qui con l’ordinaria sostituzione di piante esotiche a quelle autoctone ha subito una battuta d’arresto quando si è trovato di fronte a questo albero. E’ un Marula, una pianta che cresce solo dove decide lei, non la si può coltivare e viene ancora usata per le sue proprietà, venerata e preservata in tutto il continente africano. Ed è proprio a questo, che molti considerano il re degli alberi africani, che, durante la rivolta di Matabele, quella combattuta tra il 1896 e il 1897 dalla Compagnia Britannica del Sudafrica e dal popolo Ndebele, nove neri furono impiccati ai suoi rami, dopo processi sommari in tre casi per saccheggi, negli altri sei per spionaggio. Le esecuzioni avvennero in giorni diversi e i corpi restarono appesi all’albero che si trovava fuori dalle mura della città, a monito per tutti gli Ndebele ribelli.
Sulla stampa britannica dell’epoca, apparvero articoli, come quello pubblicato dal “Daily Graphic” il 13 giugno 1896, di nitida crudeltà. Veniva riportato che c’era un grande albero usato come forca e si spiegava come ci fosse stato “un buon raccolto, con sette Ndebele impiccati a cui poi se ne è aggiunto un ottavo…” e di come tutto questo fosse “un bel vedere”.
Un mese fa il Ministro Cde Kazembe Kazembe ha scritto al Consiglio comunale di Bulawayo per informarlo dell’intenzione di considerare l'albero un monumento nazionale a memoria delle impiccagioni avvenute e come riconoscimento dell’importanza che quella rivolta ha avuto nell’ambito del processo di liberazione del Paese. Il Comune ha prontamente risposto al Ministro dicendo che “…non vi sono obiezioni alla richiesta di dichiarare il sito e l’albero come monumento nazionale. Questo contribuirà a preservare il sito che ha un grande significato politico e storico….”
Monumento deriva dal latino monere, un verbo che può significare ricordare, ammonire, predire.
Quell’albero è a tutti gli effetti un monumento: ricorda il dolore che come europei abbiamo portato in quelle terre; ammonisce a non praticare una giustizia che al male aggiunge altro male; predice una concezione della giustizia che rivitalizzi forme riparative, di cui è intrisa la cultura africana, che sappiano ri-conoscere, ri-conciliare e ri-comporre il tessuto sociale.
La notizia di questo albero ha richiamato al mio cuore quella parte della storia di Nessuno tocchi Caino che ci portava in giro per il mondo a cercare sostegni alla risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e che ci ha condotti più volte proprio nello Zimbabwe. Ricordo l’incontro con Morgan Tsvangirai, che era stato leader del partito all’opposizione del dispotico Mugabe, il Movimento per il Cambiamento Democratico. Era il 2012 quando Tsvangirai, nel frattempo divenuto Primo Ministro, ci spiegò la sua contrarietà alle impiccagioni che considerava un “retaggio dell’era coloniale”. Lui stesso aveva rischiato la pena di morte quando era stato arrestato nel 2002 per tradimento e poi prosciolto nel 2004 dall’Alta Corte dello Zimbabwe. Storia analoga è quella dell’attuale Presidente Emmerson Mnangagwa, succeduto a Mugabe nel 2017, dopo aver rischiato di essere impiccato durante il governo dell’apartheid di Ian Smith, contro cui aveva combattuto. Nel 2018, nell’ambito di un’amnistia presidenziale rivolta a 3.000 detenuti, Mnangagwa incluse anche 16 condannati a morte che erano stati nel braccio della morte per almeno dieci anni.
Accade che solo vissuti così, di condannati a morte che poi diventano capi di stato, possano condurre a un cambiamento nella concezione della giustizia, che sappia guardare al futuro invece che pietrificarsi su fatti passati che pure sono incancellabili. A loro spetta il compito di liberare definitivamente il Paese dal regime coloniale attraverso l’abolizione di quella pena che dall’Europa è stata portata in Africa: la pena di morte.
Al Marula di Bulawayo il compito di conservare traccia di ciò che è accaduto per rievocarlo come stato di coscienza più elevato.