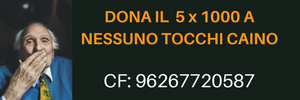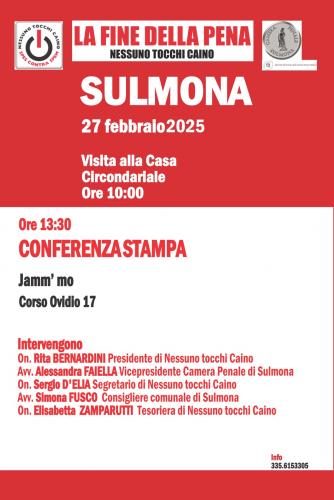08 Febbraio 2025 :
Tullio Padovani su l’Unità dell’8 febbraio 2025
Se è pacifico che le funzioni di giudice e di pubblico ministero sono eterogenee, ed anzi, potenzialmente conflittuali, a quale titolo si giustifica l’omogeneità della carriera nel contesto di un unico «ordine»? Il problema non consiste nel decidere se è necessario separare le loro carriere, quanto piuttosto nell’interrogarsi come mai siano unite.
Perché – si dice – essi devono condividere un’uguale «cultura della giurisdizione». Rompendo il legame dell’appartenenza ad un unico «ordine», il pubblico ministero uscirebbe dal seminato del diritto e si trasformerebbe in una sorta di pianta selvatica. Ma se per “giurisdizione” si intende lo ius dicere, e cioè la risoluzione di un conflitto in base alla legge, si tratta di ciò che qualifica specificamente il giudice.
Se viceversa si vuol accedere ad una nozione lata, concependo la giurisdizione come svolgimento di un’attività regolata dalla legge e strumentale per la risoluzione del conflitto da parte del giudice, bisogna convenire che la comunanza invocata per il pubblico ministero coinvolge in realtà l’intero ceto forense, ed in particolare anche la sua terza, indefettibile componente, costituita dall’avvocato difensore.
La cultura della giurisdizione, intesa in questo senso lato, autorizzerebbe l’unicità delle carriere, a condizione che ad essa concorressero tutti i componenti del ceto forense.
Ma – si dice – un pubblico ministero con carriera distinta e separata da quella del giudice finirebbe preda della funzione di governo; sarebbe alle dipendenze dell’esecutivo. Se si tratta di ipotizzare un vincolo di dipendenza gerarchica, il discorso finisce prima di cominciare, perché «il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario» (art. 107, comma 4° Cost.): non certo di tutte le garanzie stabilite nei confronti del giudice, ma di garanzie deve trattarsi; e un vincolo di dipendenza gerarchica non si iscriverebbe in quest’orbita.
Ma in effetti la questione dell’esercizio del potere d’accusa non si pone in termini di vincolo gerarchico. Il problema è il controllo sull’esercizio di tale potere “anomico e terribile”, per riprendere l’efficace espressione di Antoine Garapon. Infatti – scriveva Giovanni Falcone – «se il potere dell’accusa non comporta responsabilità, tutti la temono, sono tutti terrorizzati dai pm. Il pm si presenta come un’ombra nefasta in qualunque contesto».
Ma – si obietta – il pubblico ministero è gravato da un obbligo costituzionale di esercitare l’azione penale: indistintamente, indefettibilmente, incondizionatamente, quale garanzia di uguaglianza e di parità di trattamento. Ma pur attribuendo al pm la più ferma intenzione di assolvere a questo impegno, è impossibile ch’egli possa realizzarla, dato il numero delle pendenze in attesa. La legge stessa impone criteri di priorità nella trattazione; la loro osservanza implica necessariamente retrocessione e poi abbandono di una cospicua quota di fascicoli. Per essi, un tempo operava la tagliola della prescrizione. Ora, una volta introdotti vincoli temporali più cogenti per definire i procedimenti, è logico supporre che il canale di scolo per i casi “negletti” sarà rappresentato dalla richiesta di archiviazione.
In un simile contesto, ha senso invocare l’art. 112 Cost.? Si tratta in realtà di decidere come debba essere disciplinato il potere d’accusa nel vasto e potenzialmente selvaggio territorio delle indagini preliminari, il cui tasso di legalità dipende da una mera «notizia di reato» (quando pure sussiste), e cioè dal simulacro, o dal segmento, di un eventuale, reato.
L’esercizio del potere di accusa evoca direttive trasparenti, controllo efficiente, verifica puntuale e responsabilità definite; perché in esso si colloca il nervo motore della legalità.
A mo’ di chiusura, il viatico di un ricordo. Dopo un pomeriggio speso ad ascoltare, in un convegno sul nuovo codice, lamentazioni di pm dolenti per la presunta perdita di
dignità e potere, passeggiavo con un caro amico, pm insigne destinato a maggior gloria. «Quei minchioni – disse prendendomi sotto braccio – non hanno capito un bel nulla. Non si rendono conto che ora siamo noi i padroni del processo, e ne faremo quello che vogliamo». Confesso che allora mi sembrò un delirio o un miraggio. Imparai poi che, mentre io ero cieco, lui aveva semplicemente visto lontano: per quanto riguarda le sorti di questo Paese anche troppo.