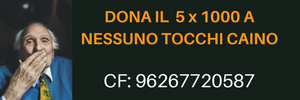19 Ottobre 2024 :
Emilia Vera Giurato su l’Unità del 19 ottobre 2024
Provo a contagiargli speranza con gli occhi, con il sorriso. Non posso fare altro per queste anime in pena. Lo sono tutte; quelle colpevoli di più perché oltre alla restrizione, alla privazione della libertà, alla luce filtrata dalle grate, all’orizzonte fatto di spessi muri grigi, portano il peso insopportabile della colpa.
Sono 38 le donne recluse nella sezione femminile del carcere di Reggio Calabria, che ne potrebbe contenere al massimo 26. Il sovraffollamento ha un impatto meno evidente rispetto alle sezioni maschili; i locali sono silenziosi, le celle (camere di pernottamento tecnicamente ma celle in verità) sono pulite, organizzate secondo un ordine forzato, che mal si concilia con gli spazi ristretti.
I bagni sono in discrete condizioni, hanno la doccia con acqua calda, il riscaldamento in inverno e la luce non manca. Ma le condizioni generalmente accettabili e l’apparenza tranquilla stridono con la sensazione di oppressione che si avverte nitidamente entrando. Il contesto scompare, esaltando la timidezza discreta delle donne rinchiuse in quelle neutre scatole di cemento, astratte dalla realtà. I loro occhi sono spenti ma grati nel vedere, per una volta, qualcuno che non indossi la divisa.
Nessuno tocchi Caino è un’associazione che conoscono bene, sanno che non sarà una visita di cortesia, sanno che non ci si dimenticherà di loro appena usciti. Con la mano aggrappata alle sbarre della cella, una donna si rivolge a Rita, di cui intuisce la rara capacità di ascoltare con cuore e anima: “…Ho fatto tanti lavori per vivere, anche cose di cui mi vergogno. Purtroppo il mio destino è questo e devo accettarlo”. Quella postura mi evoca l’istinto di aggrapparsi alla vita, nonostante quel destino, nonostante la rassegnazione e la incapacità di essere padrona della propria sorte.
In biblioteca incontriamo Daniela, mi sembra timorosa, come in bilico sul cornicione della vita; poco dopo capisco il perché di quell’impressione. Anni fa, accecata dalla gelosia nei confronti del marito adultero, ha ucciso suo figlio, sindrome di Medea; poi ha tentato di togliersi la vita, senza riuscirci. Ha smesso di parlare allora, si è chiusa in un mutismo autopunitivo per più di sei anni. Ora, grazie al sostegno, alla professionalità e alla “delicatezza” (così l’ha definita lei) degli psicologi e del personale, ha ripreso a parlare; e scrive ma non vuole pubblicare nulla perché tutto quello che riversa sulle pagine è troppo intimo. “Lo pensavo anch’io” le dico “ma provaci, filtra quello che ti senti di portare all’esterno; pensaci almeno, ti farà stare meglio, ne sono sicura e farà bene a qualcun altro”. Mi guarda con occhi dolci, profondi e smarriti.
Mi rincuora la dolcezza quasi familiare degli sguardi e dei modi delle Agenti di Polizia Penitenziaria che ci guidano perché credo che compassione e accudimento possano aiutare a smorzare il dolore della solitudine.
Prima di andar via, incontriamo Maysoon, una ragazza curda, arrestata appena sbarcata al porto di Crotone perché accusata di essere una scafista. È piccola di statura e molto minuta, anche per via dello sciopero della fame che ha portato avanti per ribellarsi all’ingiustizia del trattamento che le viene riservato. Ha occhi grandi e neri come profondi laghi di notte, intelligenti, vivi; ha imparato a parlare l’italiano in pochi mesi. È regista e attrice di teatro, costretta a scappare dal suo Paese a causa della violenta repressione nei confronti di donne e giovani. Vorrebbe uscire, Maysoon, per denunciare, manifestare, gridare per le donne del suo popolo e freme, contando i giorni che trascorre intrappolata tra le maglie opprimenti di una giustizia disfuzionale: 281. La potenza dello sguardo di quella piccola donna dalla tempra d’acciaio si scioglie in un attimo quando le chiedono la sua età: “Ventotto”, gli occhi si annacquano di lacrime e lei, dritta come un fusto, le ricaccia dignitosamente indietro.
Ci sono anche una mamma e una figlia, detenute insieme e io non posso fare a meno di domandarmi che società siamo diventati, che genere di civiltà sia quella in cui una mamma e sua figlia finiscono in carcere insieme; perché non posso credere che sia solo responsabilità loro. Mi sono rimasti dentro gli occhi di tutte queste donne. Mentre attraversiamo il corridoio per uscire, noto una panchina dipinta di rosso, simbolo del sangue versato dalle donne vittime di violenza; ci dicono che i reati per cui sono ristrette le detenute al carcere di Reggio attualmente sono spaccio e omicidio. Penso a tutte le donne uccise dalla mano di uomini e a quelle che versano il sangue altrui e poi scompaiono inghiottite dal buio pesto delle nostre carceri. La violenza non ha genere, ha a che fare con l’umanità e noi non abbiamo ancora trovato il modo di guarire.