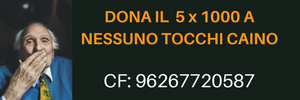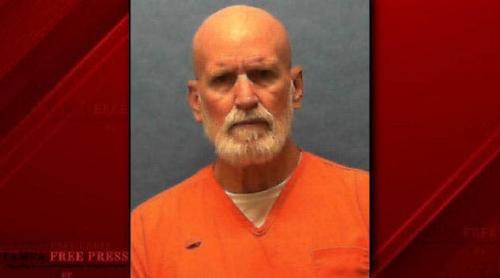23 Gennaio 2026 :
23/01/2026 - ITALIA. Riceviamo da Federica Massoli un racconto molto interessante sul suo rapporto di amicizia con un condannato a morte statunitense, Bryan Jennings, che è stato giustiziato il 13 novembre 2025 (vedi NtC in quella data).
«In relazione all’articolo pubblicato sulla pagina di Nessuno tocchi Caino in data 14 Novembre 2025, dal titolo “USA - Florida. Bryan Jennings, 66 anni, bianco, è stato giustiziato”, vi scrivo perché quel visitatore di cui si parla nell’articolo sono io.
Credo sia importante ricordare Bryan anche da una prospettiva diversa rispetto a quella offerta dall’articolo da voi tradotto e ripreso dalla testata Florida Today. Ritengo fondamentale, soprattutto, raccontarlo da un’altra angolazione: quella profondamente umana.
Il racconto che segue vuole essere il mio contributo alla battaglia contro la pena di morte, un tentativo di metterne in luce la freddezza e l’ingiustizia anche negli istanti immediatamente precedenti ad un’esecuzione. Ma vuole essere anche, e forse prima di tutto, un tentativo di restituire un volto, una voce, dei colori a chi viene troppo spesso ridotto alla prigione di una sola definizione — il condannato a morte.
La pena capitale è un omicidio legalizzato. E le sue vittime non sono simboli né numeri, ma esseri umani anche loro, con storie, affetti, paure. Dimenticarlo significa accettare che l’umanità possa essere spenta per legge. Ed è proprio questo che non dovrebbe mai accadere.
I MIEI ULTIMI GIORNI INSIEME A BRYAN FREDERICK JENNINGS
- La storia di Bryan
Bryan Frederick Jennings era nato il 9 dicembre 1958.
Quando arrivò in Florida, nel 1974, era ancora un ragazzo. Pochi anni dopo si arruolò nei Marines e venne mandato a Okinawa, dove rimase per due anni. Tornò a casa nella primavera del 1979, con una vita appena cominciata.
Pochi mesi dopo, una bambina di sei anni venne trovata morta. Era l’11 maggio 1979. Bryan era appena rientrato dall’estero, era un ragazzo sconosciuto nel quartiere, e questo bastò a annoverarlo fra le persone sospette. Aveva vent’anni quando venne incriminato. Vent’anni quando iniziò il suo cammino nel braccio della morte.
Seguì una lunga sequenza di processi: due annullati, un terzo concluso – come i precedenti – con un verdetto non unanime. Eppure, nonostante ciò, arrivò la condanna a morte. Da allora, per più di quarantacinque anni, Bryan ha vissuto sospeso tra appelli, ricorsi e attese, in una cella che misurava poco più di un corpo umano, in una vita ridotta all’essenziale.
Fino a quando – il 10 ottobre 2025, proprio nella Giornata mondiale contro la pena di morte – il Governatore ha firmato il suo death warrant, e da quel momento tutto si è accelerato. Giudici, Corti, Dipartimento carcerario, un intero sistema che, in meno di un mese, ha confermato, senza farsi troppe domande, ciò che per decenni era rimasto sospeso.
Bryan è stato ucciso con un’iniezione letale che, secondo il protocollo, avrebbe dovuto essere rapida e indolore. (1)
Non lo è stata, a quanto pare.
I giornalisti presenti nella Execution chamber raccontano di minuti difficili da guardare: il suo corpo che reagiva, il tempo che si dilatava. La morte è stata dichiarata alle 18.20, venti minuti dopo l’inizio dell’esecuzione. Solo pochi minuti in più rispetto ad altre esecuzioni, ma quando si soffre, pochi minuti sono un’eternità.
***
Il mio cammino con lui era iniziato molto prima, nel marzo del 2018.
Lessi per caso un post su Facebook della Comunità di Sant’Egidio: “Vuoi corrispondere con un condannato nel braccio della morte?”. Rimasi colpita. Ho sempre creduto che “Nessun uomo è un’isola”. Così risposi. Mi dissi che, nella peggiore delle ipotesi, avrei migliorato il mio inglese, che allora era pessimo.
Dopo pochi giorni ricevetti i suoi dati: un nome, un numero di matricola, un indirizzo, una foto. Prima di scrivergli feci ciò che non avrei dovuto fare: cercai il suo nome online. Volevo sapere per cosa fosse stato condannato, sperando che non si trattasse di un crimine contro un minore. Sapevo che quel limite, dentro di me, esisteva.
E scoprii che il crimine per il quale era stato condannato a morte era proprio quello. Mi trovai davanti ciò che per tutti rappresenta il tabù dei tabù.
Eppure, nonostante tutto, sentii di voler andare avanti.
Scrivere non mi obbligava a nulla. Le lettere erano una distanza sicura. E poi il suo volto non corrispondeva all’idea di mostro che avevo in testa pensando alle persone in prigione: gli occhi erano gentili, lo sguardo non incuteva paura.
Il vero muro era il mio pregiudizio.
E fu Bryan, con il suo garbo, la sua onestà, il suo pudore e la sua delicatezza, ad abbatterlo. Il modo in cui si avvicinò a me, cercando solo un contatto umano, trasformò rapidamente la nostra corrispondenza in un incontro autentico. Non tra colpevole e innocente, non tra detenuto e volontaria penpal, ma tra due persone. Tra pari.
In otto anni, le nostre vite cambiarono. Lui uscì lentamente da un isolamento che lo aveva condotto a una rassegnata indifferenza. Io finii con l’arricchirmi con la sua umanità e la sua saggezza, con quell’arte silenziosa di sostenermi senza pretendere nulla, trovando però, naturalmente, appoggio nella mia presenza. Un incastro perfetto, inevitabile.
Dopo alcune cause collettive vinte dai detenuti, potemmo intensificare i contatti: email quotidiane, telefonate, videochiamate, visite in presenza. La vicinanza crebbe, diventò intimità. Un’intimità dell’anima, fatta di ascolto, di verità, di nudità reciproca.
Io pensavo di entrare in carcere per portare vita in un luogo di morte. Invece trovai luce. E per otto anni ce la siamo scambiata a vicenda.
Nel 2022 il suo difensore statale d’ufficio morì improvvisamente. Bryan rimase solo. Fu allora che capii che non bastava più esserci emotivamente: dovevo fare qualcosa. Quando una persona amata ha bisogno di aiuto, si tenta l’impossibile.
Cominciai a studiare il suo caso. A leggere atti, sentenze, ricorsi. E quel crimine tanto odioso per il quale Bryan era in carcere prese in realtà contorni completamente diversi. Scoprii che le prove contro di lui erano solo circostanziali. Nessun test del DNA, nessun testimone oculare. Testimonianze fragili, contraddittorie, persino ritrattate. Eppure mai considerate sufficienti a fermare la macchina. Nemmeno la circostanza che nel 1989, l’allora Governatore della Florida avesse fissato una prima data di esecuzione, poi sospesa, proprio per l’incertezza della condanna.
Passai mesi sulle carte. Non conoscevo il diritto penale americano, ma mi convinsi di una cosa: la colpevolezza di Bryan NON era stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Scrissi una ricostruzione della sua vicenda e la inviai a decine di studi legali, nello sforzo di trovargli un nuovo avvocato disposto a lavorare pro bono per lui. Le poche risposte che ricevetti dicevano tutte la stessa cosa: una storia processuale troppo lunga, troppo complessa, perciò non se la sentivano di prendersi sulle spalle un caso come il suo.
Solo dopo il 10 ottobre 2025 e la firma della data per la sua esecuzione, solo allora, lo Stato si è preoccupato di assegnargli un avvocato. Meno di trenta giorni per rileggere 46 anni di atti. Un’impresa impossibile. Una difesa solo formale.
E un ultimo iter processuale altrettanto formale e frettoloso: ricorsi respinti in soli 45 minuti, appelli respinti senza reali argomentazioni giuridiche.
Così il 13 novembre 2025 Bryan è stato ucciso.
Aveva quasi sessantasette anni. Era un uomo gentile, generoso, profondamente buono. Aveva scelto di trasformare la sua vita in un viaggio interiore, con l’obiettivo ostinato di diventare una persona migliore.
Quando ne parlavamo e io gli dicevo ostinatamente che tutto deve avere un senso in questa vita, lui mi rispondeva sempre che il senso della vita per lui era semplicemente vivere la vita stessa nel miglior modo possibile. Cercando, ogni giorno, di essere la versione migliore di sé. Per sé e per gli altri.
Questo, Bryan, lo ha fatto fino all’ultimo respiro.
- Il mese prima dell’esecuzione
Subito dopo la lettura del mandato di esecuzione firmato dal Governatore, Bryan è stato portato via da quella che per anni era stata la sua “casa”. All’improvviso è stato strappato dalla sua cella e dalla fila di celle e di compagni con i quali aveva condiviso la vita per molti anni e, senza nemmeno il tempo di comprendere davvero cosa stesse succedendo, è stato trasferito in una prigione vicina alla sua, in una sezione chiamata Death Watch, un luogo pensato esclusivamente per chi ha già una data di morte fissata.
E’ composta da tre celle isolate dal resto del carcere. Bryan me le descriveva come tappe di un percorso obbligato: i detenuti vengono fatti “scalare” da una all’altra man mano che le esecuzioni si susseguono, come se anche lo spazio dovesse ricordare loro che il tempo sta finendo.
Appena firmato il mandato, fu rinchiuso nella prima cella. Le sbarre – da quel che mi raccontava - erano inspiegabilmente coperte da una lastra di plexiglass che gli impediva persino di scambiare una parola con gli altri due detenuti. Una solitudine dentro la solitudine. Nell’ultima settimana prima dell’esecuzione venne spostato nell’ultima cella, l’ultima fermata.
I nostri contatti, dopo il 10 ottobre, furono drasticamente ridotti. Una crudeltà nella crudeltà. Ai detenuti del Death Watch viene tolto il tablet, l’unico strumento che permette loro di mantenere un filo con il mondo esterno. Anche le telefonate vengono ridotte: da una o due al giorno, lunghe mezz’ora, a tre sole chiamate a settimana, di dieci minuti ciascuna. Dieci minuti per dirsi tutto, o fingere che possano bastare.
Le sue notizie mi arrivavano allora attraverso lettere scritte a mano. Bryan le spediva al suo avvocato o a sua sorella, che le fotografavano e me le inoltravano su WhatsApp, per accorciare l’attesa, visto che se mi avesse scritto oltreoceano avrei probabilmente ricevuto le sue lettere troppo tardi. Parole che viaggiavano come potevano, cercando di battere il tempo.
Questo fino all’8 novembre, quando sono partita per la Florida. Volevo trascorrere con lui gli ultimi quattro giorni. Avevo chiesto, e mi erano state concesse, dodici ore di visita senza contatto nei primi tre giorni della settimana dell’esecuzione: quattro ore al giorno, separati da un vetro. A queste si sarebbero aggiunte due ore, sempre dietro il vetro, la mattina stessa dell’esecuzione, e infine un’ultima ora di visita di contatto. Un’ora pensata per rendere l’addio “più umano”.
Ma di umano, in quell’ultima ora, c’è stato ben poco.
3.Il primo giorno di visita
Il primo giorno di visita non sapevo cosa aspettarmi. Non avevo mai fatto un colloquio dietro al vetro e non conoscevo le procedure di ingresso in quella diversa prigione. Ero tesa, all’erta, come se ogni dettaglio potesse diventare un ostacolo. Ed ero nervosa, perché non sapevo come avrei trovato Bryan e come io avrei reagito a tutta la situazione.
Le guardie all’ingresso, quel mattino, furono sorprendentemente gentili. Arrivai con un po’ di anticipo, erano circa le 8.40. Controllarono il passaporto, mi sottoposero a una rapida perquisizione per verificare che non avessi con me nulla di vietato, poi mi fecero sedere su una panca di legno. Alla mia sinistra si apriva un corridoio lungo, forse più di cinquanta metri, scandito da quattro cancelli di sbarre in metallo. In fondo, una scalinata di dieci, quindici gradini.
Dopo una decina di minuti, in lontananza vidi comparire Bryan in cima alle scale. Era scortato da due guardie e camminava a piccoli passi, perché incatenato ai polsi e alle caviglie. Una delle guardie lo sorreggeva mentre scendeva i gradini. Poi attraversò due dei cancelli di ferro e si fermò davanti a una porta blindata. Lo fecero entrare in una stanza: lì avrebbe trascorso l’intera mattinata, dall’altra parte del vetro.
Solo allora permisero a me di muovermi. Aprirono le sbarre del corridoio, mi scortarono attraverso gli altri due cancelli posti all’estremità opposta del corridoio e mi fecero entrare in una stanza spoglia, con – non ricordo bene- dodici o quattordici sedie di metallo allineate. Ogni sedia corrispondeva a una piccola finestra di vetro; dall’altra parte, nella stanza limitrofa, c’erano altrettante celle minuscole, poco più grandi dello spazio necessario per una sedia. E’ lì che i detenuti vengono condotti per i colloqui non di contatto.
Scoprii di essere sola nella stanza, ciononostante la porta venne chiusa a chiave alle mie spalle. Mi avvicinai alla quinta sedia. Sporgendomi in avanti vidi Bryan. Era già lì, chiuso nella sua microcella e mi sorrideva. Aveva ancora le catene ai piedi. Sarebbero rimaste per tutta la durata delle visite.
La mattinata passò in un lampo, eppure fu carica di emozioni. A tratti sembrava tutto normale, come una delle nostre visite di sempre. Poi, all’improvviso, riaffiorava la consapevolezza che entrambi cercavamo di tenere a bada: la fine era vicina, inesorabile. E proprio per questo avevamo una voglia disperata di rendere felici anche quei momenti.
Abbiamo scherzato, riso, parlato come facevamo sempre. Abbiamo persino preso in giro la guardia seduta dietro di lui, che non ci ha perso di vista un istante. Interveniva spesso, si intrometteva nei nostri discorsi con la sua voce “fuori campo”, ricordandoci che non avremmo avuto nemmeno un briciolo di intimità. Ma noi continuavamo a parlare, come se bastasse quello a difenderci.
Quella prima giornata fu travolgente. Venivo da un mese ininterrotto di tentativi disperati: contattare giornalisti e politici, scrivere a personaggi pubblici, diffondere petizioni, tenere contatti costanti con gli avvocati di Bryan e con l’associazione contro la pena di morte che aveva avviato una campagna per sospendere l’esecuzione. Amici, realtà solidali, il Comitato Paul Rougeau, la Comunità di Sant’Egidio: tutti avevano cercato di fare qualcosa. Io avevo cercato di non far pesare nulla su Bryan, di regalargli serenità, perfino allegria. Mi aveva chiesto di non raccontargli nulla, per non illudersi; eppure, col passare delle settimane, cominciò a cambiare idea, rimanendo profondamente colpito dall’ondata di amore, positività e sostegno che tante persone gli avevano donato scrivendogli e mandandogli messaggi.
Quando la visita finì e uscii da quella stanza, cominciai a piangere. Era come se tutta la tensione trattenuta per ore si fosse improvvisamente sciolta.
La guardia che mi accompagnava all’uscita era una ragazza giovane, minuta, bionda, avrà avuto venticinque anni o forse meno. Vedendomi in lacrime mi chiese: «Stai bene?». Risposi la verità: «No, in realtà no. Per me non è facile tutto questo».
Non mi aspettavo nulla. E invece lei disse: «Devo ammettere che anche io, molto spesso, faccio fatica ad accettarlo».
Non so se la prospettiva delle nostre parole in quel momento fosse la stessa, se ci stavamo riferendo alla stessa cosa, ma per me fu come un improvviso barlume di umanità in un luogo da cui non me la aspettavo più. Senza pensarci troppo le chiesi: «Posso abbracciarti?». Lei, altrettanto fuori dagli schemi, disse di sì.
Quell’abbraccio, il primo giorno, mi diede la forza di affrontare quelli successivi. Giorni in cui le guardie sarebbero state molto meno empatiche. E il peso, molto più grande.
- Il secondo e il terzo giorno di visita
Il secondo e il terzo giorno di visita l’ingresso fu più complicato. Le guardie erano cambiate, molto giovani, e alcune di loro stavano addestrando le nuove. I passaggi procedurali venivano meccanicamente ripetuti e corretti. Tutto era rallentato. Il documento di riconoscimento che il giorno prima era stato accettato senza problemi, improvvisamente non andava più bene. La perquisizione fu più goffa, meno sicura, e proprio per questo più invasiva.
Nonostante tutto, le visite furono intense. Un intreccio di dolcezza e amarezza: il piacere di stare insieme e, sotto, la consapevolezza che il tempo stava finendo. Sapevamo entrambi che non c’era nulla da salvare, se non il modo di arrivare alla fine.
In quei giorni Bryan mi fece conoscere una canzone dei Lucius, White Lies. Parla della fine di una relazione e del tentativo ostinato di vivere fino in fondo gli ultimi istanti, anche sapendo come andrà a finire. "Non voglio sapere il significato/ Ho solo bisogno di te ora/ Sappiamo entrambi come finisce/ Non c'è niente da capire".
Quelle parole ci accompagnarono come una colonna sonora silenziosa: non capire, non spiegare, solo esserci. Era esattamente quello che stavamo facendo.
Quando uscii dalla visita del secondo giorno, una giovane guardia mi osservò a lungo. Vedendomi di nuovo scossa, abbassò la voce e mi disse: «Ora che siamo off the record (lontani dai registratori) posso chiederti una cosa? Come fai? Voglio dire… come fai a gestire tutto questo?»
Le risposi senza pensarci troppo: «Infatti non è facile, come vedi. E, in realtà, sono io ora off the record a chiedere a te: come fai TU a fare questo lavoro, sapendo che le persone vengono uccise?»
Lei esitò appena, poi disse: «Siamo addestrati a non farci e a non fare troppe domande. Ci insegnano a soddisfare i bisogni primari dei prigionieri. Il resto… per noi, è solo lavoro».
Quelle parole furono una doccia fredda. Arrivarono dopo il barlume di umanità del giorno precedente e lo spensero di colpo. Da un punto di vista teorico potevo persino comprenderle: forse è l’unico modo per sopravvivere emotivamente a quel ruolo. Ma toccai con mano quanto il protocollo insegni l’assenza di umanità.
Tra lasciarsi travolgere dall’empatia e diventare freddi, distanti, quasi meccanici, esistono infinite sfumature. Ed è lì, in quelle sfumature, che si misura la dignità di un sistema. Soprattutto quando al centro non ci sono numeri o procedure, ma esseri umani. Come Bryan.
- Il giorno dell’esecuzione
Il giorno dell’esecuzione è stato emotivamente devastante.
Mentre mi preparavo, quella mattina, nella stanza anonima del motel, sapevo che stavo andando incontro al nostro ultimo giorno insieme su questa Terra. Sapevo anche che avrei dovuto fare uno sforzo enorme per non lasciarmi travolgere dall’emozione, per non piangere davanti a lui. Ma tutto era così irreale, ovattato, come se mi stessi muovendo dentro una bolla di sapone.
Appena arrivata all’ingresso della prigione, mi accorsi che l’atmosfera era diversa dai giorni precedenti. L’intera area era blindata, si percepiva che stavano mettendo in atto “una procedura”. Davanti all’ingresso principale dell’area erano state installate barriere per impedire il passaggio di auto e persone. Uno schieramento di guardie mi aveva subito fermato per un controllo preliminare dei documenti e del motivo della mia visita. Quel giorno, mi è stato poi spiegato, la prigione sarebbe stata in totale lockdown essendo “giornata di esecuzione”: nessuno avrebbe potuto entrare se non espressamente autorizzato. Erano tutti in abiti civili. Ed è stato allora che ho pensato, con una chiarezza dolorosa, che proprio quelle persone dall’aspetto ordinario, che mi stavano trattenendo all’ingresso, sarebbero state probabilmente le stesse che poche ore dopo avrebbero iniettato il veleno nelle vene del mio Bryan o assistito alla scena. Erano vestite come chiunque altro, ma appartenevano a un mondo a me completamente alieno.
Le ho ritrovate anche all’interno. E sono state loro a rendere la mia ultima ora con Bryan profondamente odiosa.
Quella mattina ci furono concesse due ore dietro al vetro. Cercammo di comportarci come se nulla stesse accadendo, ma riuscirci fu quasi impossibile. Poi ci fu concessa un’ultima ora di contatto. Proprio in quel lasso di tempo gli portarono l’“ultimo pasto”.
Nei giorni precedenti Bryan mi aveva detto che non avrebbe voluto mangiare nulla. Ma le guardie avevano insistito a lungo, fino a quando aveva ceduto, chiedendo un burger, delle patatine fritte e una soda. Quando glielo portarono per farglielo mangiare davanti ai miei occhi, rimasi senza parole. Continuavo a ripetermi mentalmente: non posso credere che questo sia davvero l’ultimo pasto, quello che si vede nei film. Cercai di non mostrarlo. Gli chiesi solo: «Com’è? Buono?».
Bryan mangiò svogliatamente e in fretta. Dietro di lui, intanto, si erano sistemate sei persone: cinque uomini e una donna. E giurerei che almeno tre di esse fossero le stesse che mi avevano fermato all’ingresso. Dopo avergli consegnato il vassoio, si erano sedute alle sue spalle e non se ne andavano. Bryan allora decise di lasciare le patatine intatte, sperando che così quelle persone si sarebbero allontanate e ci avrebbero concesso almeno un po’ di privacy.
Cosa che non è accaduta.
Quelle sei persone sono rimaste lì per tutta l’ultima ora, sedute a poco più di un metro di distanza da noi, in silenzio, ascoltando ogni nostra parola, senza mai distogliere lo sguardo da noi. Bryan era incatenato mani e piedi. Non avrebbe potuto fare nulla. E nemmeno io: prima di entrare nella stanza mi avevano tolto persino gli occhiali da lettura, forse per paura che potessero diventare un’arma. Come se in quell’ora io avessi potuto rappresentare un pericolo. Non per lui, ma per il buon esito dell’esecuzione.
A cinque minuti dalla fine ci hanno avvisato che il tempo stava per scadere. E’ stato allora che mi hanno permesso di abbracciarlo e baciarlo.
Ci hanno concesso anche un’ultima foto insieme.
Solo chi ha vissuto qualcosa di simile può capire quanto quello scatto sia lontano anni luce dalle foto sorridenti che avevamo fatto per anni nel visiting park. In quella smorfia scomposta e visibile sul nostro viso, nei nostri sguardi, c’è tutto il dolore del momento: il tentativo ostinato di strappare un ultimo sorriso alla realtà e l’incapacità totale di costringere i muscoli del viso a farlo. Resta solo una tristezza profonda, nuda che oggi fatico a guardare nel tenere in mano quella foto. È ancora troppo presto e tutta questa valanga di emozioni vissuta ha bisogno di essere messa in ordine nella mia testa e nel mio cuore.
Quando stavo per uscire, Bryan – impossibilitato a muoversi per le manette – mi ha fatto sfilare dal suo collo la collana che gli avevo regalato due anni prima e che aveva chiesto di potermi restituire. Nel prenderla, gli ho dato un ultimo abbraccio e, guardandolo negli occhi, una carezza sul viso. Poi sono stata accompagnata fuori da quelle stesse sei persone. Nella mia testa continuavo a ripetermi: sono loro che stasera lo uccideranno.
All’esterno l’aria era fredda, ma il sole era luminoso e il cielo incredibilmente terso.
La mia amica belga, il mio angelo custode che in quei giorni non mi aveva lasciata sola un istante, era lì ad aspettarmi. Mi ha abbracciato. E io sono crollata tra le sue braccia, piangendo, sfinita dopo tutta la freddezza respirata per tante ore dentro quella prigione.
Quando sono uscita erano le 11 di mattina. Alle 18 ci sarebbe stata l’esecuzione.
Le ore che sono seguite sono scorse lente e irreali. Ogni gesto, ogni parola, ogni pensiero era attraversato dalla consapevolezza che, dietro quei muri spessi e porte blindate, Bryan stava camminando verso la fine. Io ero fuori. Lui era lì dentro. Un senso di impotenza insopportabile.
Quando alle 18 è cominciata l’esecuzione, io ero di nuovo lì, fuori dalla prigione, ad aspettare che il suo avvocato – l’unico autorizzato a presenziare per lui all’esecuzione – uscisse dalla Execution Chamber. Per parlarle e chiederle degli ultimi istanti del mio Bryan. In qualche modo, con questo mio gesto, volevo illudermi di essere stata con lui fino all’ultimo.
Nei giorni successivi, rientrata in Italia, ho sentito un grande vuoto, improvviso, netto, assordante.
E, accanto, la responsabilità di trovare la forza di elaborare un’esperienza così dolorosa e verbalizzare la cruda realtà: Bryan è stato ucciso dallo Stato, ma ciò che resta dopo un’esecuzione non è la giustizia. Resta un’assenza che si allarga. Resta un dolore che non ha testimoni ufficiali, né rituali di chiusura. Resta la vita di chi rimane, costretta a continuare portando con sé qualcosa che non può essere archiviato.
Sopprimere una vita non può restituirne un'altra, e non diventa giustizia solo perché è uno Stato a farsene carico.
Nessuna società è più sicura dopo un'esecuzione. È semplicemente più fredda, più dura, più disumana. E un sistema in cui la vendetta diventa istituzionale, in cui le istituzioni si arrogano il diritto di fare ciò che proibiscono agli altri, è il fallimento assoluto della giustizia.»
---
1) Il protocollo prevede la somministrazione di 3 diverse sostanze: la prima ha effetto sedativo, la seconda effetto paralizzante, la terza è la droga che uccide.