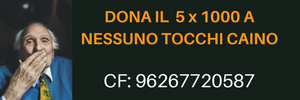21 Maggio 2023 :
Elisabetta Zamparutti su L’Unità del 21 maggio 2023
In Iraq ci sarebbero almeno 400 donne che da oltre quattordici giorni stanno conducendo uno sciopero della fame. Non sono detenute comuni. Sono tutte dell’alta sicurezza. L’accusa è la più pesante che ci possa essere: jihadiste, appartenenti all’ISIS.
Sono russe, turche, azere, ucraine, siriane, francesi, tedesche, finanche americane. Le loro condanne vanno dai 15 anni di carcere alla pena fino alla morte se non anche alla pena di morte.
Con loro, detenuti, ci sono anche un centinaio di bambini. Bambini nati in carcere. Bambini morti in carcere. L’ultimo, un bambino di tre anni. Recluse e reclusi nel carcere di Rusafa, a est di Baghdad. Un video trafugato, diffuso dalla BBC, rivela che sono stipate anche in 40 in un’unica cella.
Se alcune hanno riconosciuto di aver liberamente scelto di entrare a far parte dell’ISIS partecipando anche ad azioni violente, altre vi sono state costrette. C’è chi con insistenza ha detto di aver dovuto sposare un combattente islamico, minacciata di morte se si fosse rifiutata. A questi uomini è poi accaduto, con la caduta dello Stato islamico nel 2017, che la furia violenta che hanno seminato gli si sia ritorta contro.
Decine di migliaia di militanti sono stati catturati, molti giustiziati sommariamente. Alle migliaia di loro donne e bambini, salvo chi è stato rimpatriato nei Paesi di origine, è toccata in sorte la detenzione nelle galere della Siria e dell’Iraq. Ed è qui che queste donne, stremate da una vita che le ha portate a conoscere anche il modo in cui quella che si chiama “giustizia”, dal processo al carcere, si può abbattere su un essere umano, hanno deciso di non mangiare più, alcune anche di non bere più. Sono emaciate, stese immobili sul duro pavimento di pietra del carcere. All’inizio di questo sciopero bevevano meno di un bicchiere d’acqua al giorno. Poi alcune hanno deciso di rifiutare anche questo. Lo fanno per dire che il processo che hanno subito non è stato giusto. Lo fanno per dire che le condizioni di detenzione sono disumane. Il mese scorso il Ministro della Giustizia iracheno, dopo aver licenziato il direttore del penitenziario di Rusafa per via delle immagini che da lì sono uscite, ha ammesso che vi è il quadruplo delle detenute che potrebbero stare in quella struttura.
Caino allora oggi è lo Stato. E Caino per queste donne oggi è il carcere.
Il carcere che così come è concepito e organizzato nella vita quotidiana, rappresenta un’istituzione totale maschile. Lì dentro tutto è volto a rispondere all’aggressività e alla violenza con regole speculari che fanno vincere i valori maschili. Vi è una tremenda assenza di considerazione della componente emozionale che è propria di ogni essere umano ma che più naturalmente sono le donne a esprimere. I corpi inermi di queste detenute nel carcere di Rusafa che non sappiamo se stiano continuando o no il loro sciopero della fame ci impongono allora di tendere loro la mano, rinchiuse come sono non solo in uno spazio fisico, ma anche emotivo. Tutto il mondo è paese e il carcere è tale in tutto il mondo. È duro. È maschio e rende la condizione detentiva femminile carica di una componente afflittiva ulteriore.
Quelle 400 donne jihadiste ci chiedono aiuto e al contempo ci aiutano a meglio confrontarci con la dimensione femminile della detenzione che noi stessi trascuriamo per l’entità numericamente inferiore a quella maschile e perché poco propensi a comprendere le ragioni della “devianza” femminile.
Leggo sulla Treccani che “Cesare Lombroso, universalmente riconosciuto come il fondatore dell’antropologia criminale, fu il primo a tentare una analisi sistematica della problematica della delinquenza femminile, individuando, nel suo testo del 1893 intitolato La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, nella maggiore debolezza e stupidità delle donne rispetto agli uomini la causa della minore diffusione della criminalità femminile.”
Ecco, è proprio lasciandoci passare sulla testa considerazioni come questa che tutto un mondo di garanzie e valori nonviolenti, di cui il mondo femminile, come ha detto Mariateresa di Lascia, è un portato formidabile, lasciano spazio a una giustizia senza grazia. Non è un caso se proprio lei, all’atto della fondazione, volle quel riferimento a Caino nel nome della associazione, a riprova di una necessità che anche nel male, può sembrare paradossale, occorre in fondo sapere amare. Perché nei confronti dei due fratelli, Caino e Abele, Dio, per essere pienamente in ascolto di Abele interroga anche Caino e per fare piena giustizia del sangue di Abele si prende cura di Caino. Non lo inchioda a un fatto passato ma, in un processo di consapevolezza dove il carcere non figura mai mentre è serrato il dialogo, gli dischiude un dopo da vivere.