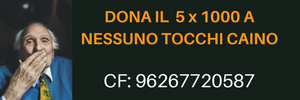28 Gennaio 2024 :
Bernardo Petralia* su L’Unità del 28 gennaio 2024
Visitare le carceri da parte di un comune cittadino provoca un solo pensiero: spero di non finirci dentro! Visitare il carcere per un avvocato ha una funzione diversa, di sostegno e di assistenza. Ha ancora un significato diverso per le associazioni che lo frequentano. Per un capo DAP, invece, visitare le carceri ha un valore del tutto diverso, che si condensa in poche parole: senso di colpa.
Ho visitato circa 50 istituti nel periodo più duro, più cupo, quello del Covid. E non c’è stata volta in cui, andando per le sezioni e incontrando carcerati di tutti i tipi, che a volte mi chiamavano anche per nome, non mi abbiano detto “scusi, vuole accomodarsi un attimo nella mia cella, prego…”. Ne ricordo uno, una persona anche istruita, con un certo piglio culturale, in una camera tutto sommato accettabile, che mi dice: “guardi, io come vede ho il bidet. So che è un lusso, toglietemelo, non mi serve, me la vedo io, datemi un bagno alla turca, va benissimo”. Aveva anche un letto sufficientemente, non voglio dire comodo, ma gradevole. E così soggiunge: “Levatemelo, datemi una stuoia, io dormo per terra, non ho problemi… Ma una cosa vi chiedo: datemi un lavoro, un lavoro che io la mattina possa svegliarmi e non pensare solo alle sigarette, a cosa fare o non fare. Datemi un lavoro, qualunque esso sia!”. Questo è uno dei grandi crucci che compongono la scacchiera del senso di colpa di un capo DAP. E col lavoro quel che serve è anche tutto ciò che gli sta attorno: la cultura, il teatro, la possibilità di creare, tutto quello che può servire a riempire non la giornata ma l’anima delle persone che abitano lì dentro.
Un secondo aspetto che accresce il senso di colpa è la non uniformità del trattamento. Per quanto non si faccia in generale quel trattamento che la Costituzione vuole, mi sono sempre interrogato sul perché, se io visito un istituto del Sud e di un certo sud, il trattamento è totalmente diverso da un istituto del Nord? Perché una persona che dalla libertà passa alla detenzione deve soffrire di più se per fattori più o meno casuali, per collegamenti territoriali con il reato commesso, quindi, per vicinanza con l’autorità giudiziaria, deve andare a finire in istituti che non assicurano quel minimo che serve solo a immaginare cosa potere fare ai fini di un trattamento? Questo senso di colpa ha rappresentato per me, giorno per giorno, uno degli scrupoli più feroci nel periodo terrificante del Covid. E inoltre, con un’organizzazione sanitaria regionalizzata che non garantisce uniformità del trattamento in tutto il Paese, con istituti in cui la sanità è brillante e altri dove invece è carente.
C’è dunque una disparità di trattamento che crea nel macrocosmo penitenziario una situazione inaccettabile. E la sanità è uno dei più gravi problemi quotidiani, dal momento che, per l’assenza del lavoro e di occupazione, l’ozio forzato fa ammalare di più. Infatti, uno dei grandi crucci di un capo DAP che gira per gli istituti è quello della presenza, eccessiva, dei detenuti “psichiatrici”, che in carcere non dovrebbero stare, bensì nei luoghi a essi deputati dove avere le cure dedicate che non siano solo una distribuzione pillolare. Questi luoghi si chiamano REMS. Ma come la sanità anche le REMS sono regionalizzate e tuttavia il loro numero è insufficiente e poco o nulla si fa per incrementarne la presenza. È facile immaginarne le conseguenze: una quantità intollerabile di detenuti psichiatrici ristretti in istituto. Dico sempre che pur avendo fatto due anni il capo DAP è come se ne avessi fatti quattro, perché non dormivo e ancora oggi risento di quell’incostanza notturna.
Un altro problema che aumenta il senso di colpa trasformandolo in angoscia, è quello dei tossicodipendenti in carcere. Un numero spropositato che comporta conseguenze inaccettabili. Intanto, la brevità della pena non dà luogo ad alcun serio trattamento; poi, non c’è la giusta attenzione sanitaria nei loro confronti. Nel Nord Europa, in Paesi in cui la civiltà ha prodotto risultati importanti nel panorama penitenziario, in alcuni istituti ai tossicodipendenti, negli ultimi anni di pena, si dà la libertà sulla parola e c’è la distribuzione periodica delle siringhe. Se è vero come è vero che la droga in carcere c’è sempre, perché non ne prendiamo atto e fuori da ogni inganno e da ogni ipocrisia cominciamo a pensare a una distribuzione delle siringhe per una tutela sanitaria collettiva? Senza contare che mantenere in carcere questo tipo di popolazione crea altri problemi di contagio anche epidemico, di induzione all’uso di sostanze.
Allora, un povero – meschino diremmo dalle mie parti – capo DAP che si trova a girare gli istituti nel periodo di una pandemia terrificante come quella che abbiamo vissuto, non può che aumentare il senso d’angoscia e pensare seriamente che quel mondo carcerario che in quarant’anni di magistratura si credeva d’avere conosciuto invece non lo si conosceva affatto. La verità è che il carcere bisogna viverlo, conoscerlo, bisogna capire che – e non voglio spingermi oltre – il carcere così com’è serve a poco. Ogni sforzo deve essere fatto non solo per chi è dentro, ma anche per quando si esce, perché la liberazione porta con sé e a lungo tempo una vibrazione di detenzione ancora. Nel dopo c’è qualcosa di ugualmente afflittivo dato che gli ex carcerati hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, enormi difficoltà di reinserimento lavorativo. Occorre in definitiva rifondare il senso di rispetto e di dignità di chi viene alla fine liberato.
*già capo del DAP, sintesi dell’intervento al X Congresso di Nessuno tocchi Caino