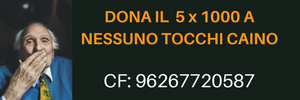04 Febbraio 2024 :
Tullio Padovani* su L’Unità del 2 febbraio 2024
Devo essere sincero e lo dico con amarezza: in questo momento non abbiamo ragioni di ottimismo. Vediamo continuamente peggiorare una situazione che è già tragica; ci si chiede come possa peggiorare, ma noi rappresentiamo l’esempio concreto e vivente di come si riesca mai a raggiungere il fondo, perché il fondo sta sempre un passo più in giù. Si potrebbe dire, e non a torto, che la situazione corrisponde al moto ondulatorio del carcere, che si ripete e si riproduce fin dalla sua origine, con una tendenza a picchi in alto e abbassamenti vistosi, sia per quanto riguarda l’andamento della popolazione carceraria sia per le condizioni carcerarie in generale. Stiamo vivendo purtroppo in una fase tanto bassa quanto critica. Del resto anche le fasi migliori, da noi, sono sempre brevi e, purtroppo, anche piuttosto occasionali. Alla fine, il catalogo dei mali del nostro carcere resta il solito, mentre la loro gravità risulta drammaticamente accresciuta ed esasperata.
Il sovraffollamento, che non è mai venuto veramente meno – a volte si è attenuato, ma cessato davvero mai – si prospetta ora in crescita rapida e vistosa, che rende ancora più inumana e ancora più degradante una esecuzione penale che è già, per conto suo, largamente fuori dalla legge, con connotati di intrinseca criminosità. Il numero dei suicidi (dei suicidi noti, perché degli ignoti non possiamo dire, ma è indubbio che ce ne siano) è già di per sé impressionante e attesta, con un tetro sigillo, che il nostro è un ordinamento che ha sì abolito la pena di morte, ma solo per sostituirla con la morte per pena.
L’altra faccia dei suicidi sono gli psicofarmaci, che costituiscono il modo attraverso il quale ci si industria di evitare i primi, quando ci si riesce. I dati sono più che allarmanti: sono drammatici. Si consuma in carcere un quantitativo di psicofarmaci che è cinque volte quello che si consuma nella media nazionale e la frazione riservata alle sostanze che si utilizzano per le sindromi più gravi, gli antipsicotici, rappresenta il 60%. Coloro che versano in carcere in una situazione clinica da trattamento psichiatrico sono certo in numero elevato, e molto elevato, ma non tanto elevato quanto la platea di coloro che di fatto ricevono un trattamento farmacologico. Questo rappresenta semplicemente un comodo strumento per mantenere l’ordine e la disciplina attraverso stordimento ed abulia.
Ordine e disciplina costituiscono – come è noto – le caratteristiche strutturali storiche del carcere. Oggi, per mantenerli si ricorre anche al controllo chimico, in una forma destinata a devastare in maniera permanente gli sventurati sottoposti a un simile trattamento. Usciranno dal carcere persone, non che riabilitate (parola che non bisogna nemmeno sussurrare nel mondo reale), non che debilitate nel fisico, non che piegate nel morale, che saranno semplicemente distrutte nella salute e nella dignità. La pena limitativa e privativa della libertà personale deve sì colpire la libertà personale, ma deve anche salvaguardare tutto ciò che non è necessariamente connesso a un regime detentivo: tutto ciò che esso consente deve essere consentito, anche in funzione di quella finalità rieducativa tanto sbandierata, che se fa comodo enunciare, non può diventare scomodo cercare di realizzare.
Per carità, non mi faccio illusioni; anzi, so per certo che il carcere non è rieducativo, non lo è mai stato e non potrà mai esserlo. Sarà bene chiarire il punto. Il carcere ha tre caratteristiche che sono inscritte nelle strutture stesse dell’istituzione, e che non si possono cambiare se non eliminando il carcere stesso. Il carcere è un’istituzione totale. Il carcere è un’istituzione marginale. Il carcere è un’istituzione simbolica. Il carcere è tutte queste tre cose insieme contestualmente. Toglietene una, non sarà più carcere.
È un’istituzione totale perché è un universo disciplinare finalizzato alla propria esclusiva esistenza: esiste per conservarsi; ha questo unico vero scopo reale. Sono tanto immanenti, ordine e disciplina, alla struttura carceraria, che qualsiasi mezzo per ottenerli è buono: per l’appunto, anche gli psicofarmaci, l’ultimo strumento disciplinare che è anche il più comodo, perché il più silente, il meno visibile, il meno vistoso. Attraverso il controllo coercitivo minuto dei tempi, degli spazi, degli spostamenti, delle condotte, di ogni manifestazione della vita corrente si esplica una tecnica volta a rendere docili i corpi e uniformate le menti. Massimo di disciplina che raggiunge il massimo dell’ordine. Questa l’essenza, questa la natura, questa l’operatività.
Ma è poi anche un’istituzione marginale, nel senso che la condizione dei detenuti e degli stessi detenenti deve rappresentare ciò che di peggio una società può offrire in un contesto dato. Se non è marginale, non è un carcere, e si trasforma in un’istituzione di assistenza, che non potrà risultare totale e, come vedremo, nemmeno simbolica. Deve essere il peggio di una società, il peggio relativo naturalmente: il peggio in Norvegia non è il peggio in Italia, il peggio negli Stati Uniti non è il peggio in Francia, e così via dicendo. Ognuno ha il suo ‘peggio’. Spesso questi ‘peggio’ si assomigliano. Tra i paesi dell’Unione europea il peggio è verosimilmente abbastanza simile tra le varie realtà. Il carcere tedesco sarà magari meno peggio sotto il profilo di certe condizioni materiali, ma sarà forse anche peggio su altri profili di natura disciplinare. Insomma, ognuno ha le sue piaghe e le sue infezioni. L’importante è che il carcere sia il luogo più triste, il luogo più esulcerato di quella società, perché se non lo fosse finirebbe col diventare un improprio polo d’attrazione, come diceva Enrico Ferri. Progressista, socialista, combattente per i diritti dei lavoratori e difensore dell’umanità, visitando le carceri, Enrico Ferri si stupì perché notò un vitto troppo ‘pregiato’. I miei contadini, nel Polesine – scriveva – non mangiano così, eppure non hanno commesso delitti. Il carcere non appariva abbastanza marginale e proprio rendeva perplesso addirittura Enrico Ferri, un uomo assolutamente al di sopra di ogni sospetto nella sua epoca. Ma nessuno lo è quando si tratta di carcere: nessuno è al di sopra di ogni sospetto.
Ma il carcere non è solo un’istituzione totale, non è solo un’istituzione marginale, è anche un’istituzione simbolica, altamente simbolica, perché ciò che gli dà significato nella società non è ciò che esso è. Il carcere è un universo disciplinare, ma non è questo che gli consente di esprimere un significato. Il significante, ciò che il carcere significa, non corrisponde al significato, perché, appunto esso assume una funzione simbolica, rappresenta un’altra cosa. Rappresenta la separazione del bene dal male, quindi, la sicurezza dei buoni e il castigo dei malvagi. Ma guarda che bella cosa! Che meraviglia! Viviamo in una società dove il bene viene separato dal male, dove i buoni sono al sicuro, la notte dormono tranquilli perché i cattivi stanno tutti chiusi nelle loro celle, dove – naturalmente – si farà di tutto per renderli «buoni», utili alla società: rieducati. Così si pensa del carcere fin da quando è stato istituito 250 anni fa. Ha questa funzione edificante, rassicurante, che costituisce dal punto di vista pratico quello che i toscani definiscono simpaticamente una novella da raccontare a veglia. Da svegli, ci raccontiamo le novelle, e così ci addormentiamo, serenamente. Gli incubi ci attendono se mai al risveglio. Ma gli incubi del carcere non turbano quasi nessuno. Il sonno della ragione indotto dalla sua esistenza non conosce se non episodici e saltuari risvegli.
Queste tre caratteristiche fondamentali vi dicono che quel che si può predicare del carcere – in termini di rinnovamento, elevazione, emenda, rieducazione, usate pure le parole che volete – appartiene alla mitologia. La mitologia penitenziaria è analoga alla mitologia di qualunque società, che elabora narrazioni parallele alla realtà proprio per compensarne le deficienze e sublimare così le proprie aspirazioni. Intendiamoci, però: questa mitologia ha un senso, ha un’utilità, come tutte le mitologie, del resto. Può infatti essere uno strumento per ottenere condizioni meno peggiori. Se la pena dev’essere rieducativa, se ci si vuol credere o far finta di crederci, è giocoforza che le condizioni siano meno peggio di quel che sono. La marginalità, del resto, è elastica, almeno relativamente, e bisogna, quindi, che si riporti il carcere a una condizione in cui quegli scopi edificanti, certo, resteranno dove sono: nel mito, ma sarà almeno salvaguardata la dignità umana.
Quindi l’obiettivo da fissare è definire in termini giuridicamente vincolanti i limiti della condizione carceraria, smorzandone il carattere tetramente disciplinare e contraendone la marginalità. Chi entra in carcere deve allora avere certezza assoluta dei suoi diritti elementari, quelli dello spazio che gli compete, delle condizioni del letto, dell’aria, dell’acqua. Deve avere un diritto definito su questi dati elementari, e deve trattarsi di un diritto vincolante per l’ordinamento e quindi coercibile. Può essere coercibile in un modo solo: attraverso il sistema che ogni ordinamento utilizza per la coercizione, nel senso che il giudice, in questo caso il magistrato di sorveglianza, sia titolare del potere-dovere di chiudere gli stabilimenti penitenziari che non sono conformi alle regole minime; un potere sacrosanto, ed elementare, se di legalità si parla e se di legalità si tratta.
Si chiudono gli alberghi che non corrispondono alle condizioni adeguate a ricevere ospiti in condizioni di sicurezza, in condizioni di salute, in condizioni di igiene, e invece si tengono aperte carceri che non sarebbero in grado di ospitare nemmeno i maiali, secondo la normativa dell’Unione europea. Il magistrato deve assumere questo potere-dovere e disporre degli strumenti per attuarlo: strumenti tecnici per accertare, da un punto di vista rigoroso, se sono rispettate le regole minime, perché, se non sono rispettate, le chiude quelle carceri, le chiude, e le chiude – vivaddio – dall’oggi al domani. E i detenuti dove li manda? Ah, lui non li manda, ci pensi chi li deve mandare, non è affar suo, lui fa quello che deve e non può non fare. In questo modo, si finirebbe con gli abusi, perché improvvisamente, io credo, se esistessero queste garanzie, i bilanci dei ministeri interessati diventerebbero meno asfittici rispetto alle spese necessarie. Siccome non si potrebbero veder chiudere tutte le carceri fuori regola, si moltiplicherebbero i casi di carceri come Bollate, che risulta discreto, soprattutto rispetto a certi luoghi di dannazione dove si sconta l’inferno prima di morire e senza gli adeguati peccati a corredo della sanzione. Bollate non sarà forse il paradiso in terra, ma ci si potrebbe certo accontentare, almeno per ora. Se tutta Italia fosse Bollate avremmo fatto appunto un primo passo verso un minimo di civiltà.
A proposito del numero, l’altra condizione per recuperare un livello minimo di tollerabilità del carcere, che oggi non solo non è tollerabile, ma è un illecito pietrificato, è rappresentata dall’introduzione del numero chiuso. In nessuna istituzione civile è consentito ammettervi all’interno più persone di quante essa può accogliere. In una sala da ballo più di x persone non ci possono entrare; in un cinema, in un teatro, più di tot persone non ci possono stare; in un albergo non si possono ospitare legioni di persone, ma solo il numero che corrispondente alle camere disponibili. Perché nelle carceri siamo invece in presenza di un elastico che s’allunga senza limiti e in forma incontrollata? Certo che si può fare, perché i diritti sono vaghi e stanno solo sulla carta, sono cioè parole al vento: quindi si può fare tutto. Il numero chiuso, invece, starebbe a indicare, sulla targa del carcere, che in quell’edificio più di x persone non ci possono entrare: una in più entra solo se una esce liberata. Per farlo, se è necessario, si sceglierà quella che ha il fine pena più prossimo, che è in condizioni personali più adeguate a eventuali misure sostitutive; ma si libera, si libera la fascia marginale che di lì a poco del resto sarà liberata comunque. Si crea un turnover rappresentato da un meccanismo facilmente governabile con tutti gli algoritmi di cui oggi disponiamo. L’espediente è cosa banalissima e, sia chiaro, non è un’idea mia, l’hanno applicata in California, e recentemente mi pare sia Amnesty che l’ha pubblicamente sostenuta. È talmente ovvia che non se ne parla proprio perché, a parlarne, tutte le persone ragionevoli direbbero: perché no?
Il cammino verso condizioni minime di civiltà non esige immense riforme, perché le immense riforme non le avremo. È inutile che continuiamo a dire: non abbiamo gli psicologi, non abbiamo il lavoro, non abbiamo questo, non abbiamo quest’altro, manca anche l’acqua, spesso e volentieri manca il caldo d’inverno, il freddo d’estate, manca tutto. È inutile che facciamo ogni volta il catalogo di quel che dovremmo avere, tanto – con questo assetto normativo – non ce lo daranno, anche perché la marginalità dell’istituzione giustifica ogni restrizione negativa. Almeno sul piano della tutela dei diritti inviolabili, sanciti a tutti i livelli, anche se spesso in modo pericolosamente elastico, qualche cosa si può e si deve fare. Il cammino è lungo perché ci ritroviamo tra i piedi i cascami persistenti della riforma penitenziaria del 1975: la radice dei mali, perché ha incrementato parossisticamente il carattere disciplinare del carcere, rimettendolo alla discrezionalità dell’amministrazione. Naturalmente in nome del grande ideale della rieducazione, che era l’Eden da raggiungere. Baggianate che hanno ingannato gli ingenui e favorito i cinici.
Abbiamo un’eredità pesante sulle spalle, e un lungo cammino da percorrere, sforzi atroci per ottenere risultati minimi. Ma non importa quanto tempo ci vorrà, non importa quanti sforzi saranno necessari, noi continueremo a insistere, non ci fermeremo mai. Noi saremo sempre quelli della “spes contra spem”, anche se, sia chiaro, per andare “contra spem”, contro una “spem” di quelle dimensioni, ci vuole una “spes” grande, grande, così grande che è difficile immaginare quanto. Ma noi ce l’avremo.
* Presidente d’Onore di Nessuno tocchi Caino