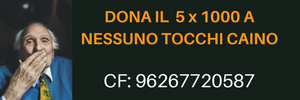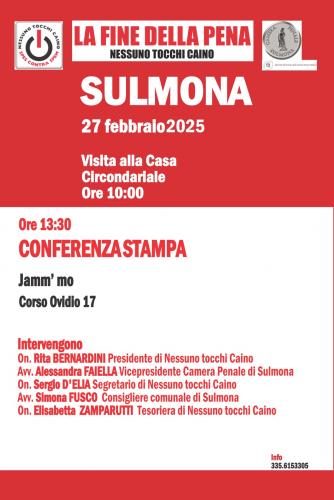08 Febbraio 2025 :
Emiliano Silvestri su l’Unità dell’8 febbraio 2025
Il 16 gennaio scorso la Camera dei Deputati ha finalmente – la prima discussione in Assemblea risale al 9 dicembre 2024 – approvato in prima lettura il disegno di legge costituzionale contenente, tra l’altro, la separazione delle carriere tra magistrati della pubblica accusa e colleghi della magistratura giudicante. Oltre alle forze di governo (il DDL porta la firma del Presidente Meloni e del Ministro Nordio) il provvedimento ha raccolto il consenso dei deputati di Azione e +Europa e l’astensione di quelli di Italia Viva: opposizione divisa e risultato di 174 voti a favore, 92 contrari e 5 astenuti.
Molti sono i critici di questa riforma, a partire dagli esponenti di Magistratura Democratica che hanno proposto di abbandonare, presa la parola il ministro o uno dei suoi delegati, le aule delle celebrazioni per l’inaugurazione dell’anno giudiziario; per arrivare all’Associazione Nazionale Magistrati che, condivisa quella proposta, ha deciso anche una giornata di sciopero della categoria per il prossimo 27 febbraio.
Non sono un giurista e non entrerò nei tecnicismi di questa riforma. Ritengo, però, non sia inutile offrire il mio ricordo di assiduo frequentatore – prima come tecnico poi anche come giornalista di Radio Radicale – delle aule del Palazzo di Giustizia di Milano in anni ormai lontani.
Chi fosse entrato in una di quelle aule prima del 24 ottobre 1989, giorno in cui entrava in vigore il “nuovo” Codice di Procedura Penale (Pisapia-Vassalli), si sarebbe trovato di fronte a una grande cattedra posta su di una pedana. Dietro questa cattedra avrebbe visto seduti affiancati i giudici del Tribunale, il Presidente del collegio giudicante e il Pubblico Ministero; questi ultimi due seduti su poltrone con uno schienale più alto degli altri; oltre la loro nuca. Uno schieramento inquisitorio destinato a preoccupare non poco l’imputato che, dal basso come il suo difensore, guardava tale rappresentazione della potenza dello Stato; era forse questo il proposito del legislatore fascista autore del Codice di Procedura Penale del 1931 (come del Codice Penale tuttora in vigore, peraltro).
Dopo la riforma del 1989 le cose cambiarono. Il Pubblico Ministero veniva sistemato in aula, di fronte al Tribunale. Al suo fianco, all’altro lato dell’aula, sedeva l’avvocato difensore. Per motivi probabilmente legati a carenza di fondi il P.M. manteneva la sua poltrona con l’alto schienale mentre l’avvocato difensore sedeva su di una normale sedia, talvolta imbottita. Un altro retaggio del passato, questo non imputabile a questioni di bilancio, si manifestava all’atto del ritiro in Camera di Consiglio dei magistrati giudicanti. Il Presidente comunicava un’ipotesi di orario per la lettura del dispositivo della sentenza. Invitava gli avvocati a presentarsi all’ora stabilita (che poteva comportare attese anche non brevi) e comunicava al Pubblico Ministero che sarebbe stato avvisato, tramite telefonata al suo ufficio, nell’imminenza del rientro in aula dei magistrati.
Il 23 novembre 1999, entrò in vigore il nuovo art. 111 della Costituzione e, probabilmente, certe abitudini cominciarono a cambiare. Più difficilmente la forma mentale dei giudici, abituati a considerare i rappresentanti della pubblica accusa come colleghi, cui magari dare del “tu” e gli Avvocati come ospiti, più o meno graditi. I fautori della separazione delle carriere possono essere lieti di questo primo passo di un lungo percorso. A mitigare la loro soddisfazione provvedono, però, altre notizie.
La prima è l’oblio su Marco Pannella che, con il Partito Radicale, per primo propose la separazione delle carriere, anche con referendum. Fu portato alle urne il 21 maggio del 2000, ma non ebbe effetto per mancato raggiungimento del quorum, anche se il 69% dei votanti (32% degli aventi diritto) condivise la proposta. La seconda è relativa al decreto sicurezza approvato dal Senato il 17 gennaio scorso: 90 milioni di euro vengono messi a disposizione di un commissario che dovrebbe sovrintendere alla costruzione di nuove, futuribili, carceri (nel frattempo in galera, carcerati e agenti continueranno a suicidarsi). Di per sé, una decisione non necessariamente terribile; se non fosse che i fondi vengono reperiti da tre poste di bilancio: il fondo per la magistratura onoraria; il fondo per la giustizia riparativa; i fondi destinati a ristorare, da una parte dei danni subiti con la detenzione, le vittime di errori giudiziari. Scelta destinata a raffreddare qualunque entusiasmo; a getta re un ulteriore tetro mantello sul futuro del sistema penale di questo nostro disgraziato Paese.