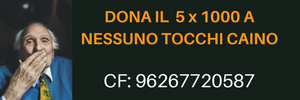20 Marzo 2022 :
Antonio Aparo* su Il Riformista del 18 marzo 2022
È un tema letterario ricorrente quello del prigioniero che ritrovandosi messo ai ferri, afferra l’uncinetto e sferruzza la catenella per allentare le catene della vita. Io ho scelto il ferro dell’ago, io ricamo. I compagni mi guardano e non comprendono la fatica del corpo su uno sgabello, della schiena piegata, delle mani pazienti e rapide, la passione delle dita, degli occhi concentrati dodici ore al giorno in silenzio, alla luce incerta di una lampadina, ma così io racconto. Perché il cuore non scoppiasse e la mente non impazzisse ho preso ago e rocchetto tanti anni fa e nel filo che scende e risale ho cominciato a imprigionare i giorni, i mesi, gli anni, mentre il tempo si è messo a tessermi le rughe in volto. Curvo la schiena su idee che prendono la forma di fili colorati, accolgo la storia che la tela mi offre come accettazione della vita e imparo a renderla al meglio. La stoffa è data come la vita, a me la possibilità di renderla migliore. In ogni ricamo racconto quello che non ho saputo fare e che ho imparato: serro il filo nell’ago, entro nella tela e raggiungo il rovescio, sfogo la voglia di tornare indietro e invertire il corso degli eventi, risalgo e poi rientro, cucire e scucire diventano processi di revisione interiore. Infilo lo sguardo sul fondo di un ricordo, seguo la legge del passo, trasformo il vuoto in un punto, ripasso le ragioni, comprendo gli errori.
Era il 16 giugno 1990, una sera d’estate in cui la guerra di mafia arroventava la Sicilia già calda e io ero a casa sotto misure di prevenzione, che mi confinavano alla mia città con tre timbri al giorno. Arrostivo carne e verdure quando sentii le scariche di armi da fuoco. Mi affacciai dalla balaustra del terrazzo, due uomini si avvicinavano di corsa a un corpo straziato a terra, uno gli sparava un colpo alla nuca, rientravano veloci in una macchina in moto e si dileguavano. A terra un ragazzo inerme. Mio fratello. Mi precipitai in strada, sperando fosse ancora vivo, lo presi fra le braccia e con le mani cercavo le ferite e la vita, ma mi ritrovai imbrattato di sangue e di una strana materia vischiosa, era il suo cervello. Mio fratello era un uomo enorme, lo caricai in auto con l’aiuto di mia sorella Teresa e senza patente guidai fino all’ospedale di Siracusa, dove lo lasciai con lei su una barella per precipitarmi di nuovo a casa affinché non mi arrestassero per violazione degli obblighi. Con la morte di mio fratello, la mia casa un tempo felice, fu avvolta dal silenzio. Poi ho perso mio padre e poi un figlio che non ho mai conosciuto, perché mia moglie era incinta.
Fui arrestato con un pretesto il 5 luglio 1990, quasi subito insomma, e non ebbi il tempo di vendicarmi. Due mesi dopo furono arrestati gli assassini di mio fratello, Tarascio, Bottaro, Di Benedetto, perciò pensai che prima o poi mi sarei vendicato in carcere. Ho trascorso 27 anni e due mesi al 41 bis, poi da Novara sono stato trasferito a Voghera, dove giungevano altri detenuti, finché arrivò un ispettore, mi porse una lista di nomi, mi chiese se qualcuno di quelli potesse essere un problema. Dissi di no, poi fui accompagnato in magazzino a ritirare la mia fornitura e finalmente in sezione. Lì notai un uomo che tremava vicino al frigorifero, aveva il morbo di Parkinson, ma io lo riconobbi: era l’assassino di mio fratello. Sentii il dolore riemergere dalle viscere della terra ed entrandomi dai piedi risalirmi tutto il corpo. Mio fratello, mio padre, mio figlio. Ora lui era davanti a me, il dolore offrì la mano all’odio che mi disse: «Fallo ora, fallo subito, non avrai un’altra opportunità. Sono 27 anni e tre mesi che attendi!». Ero un felino pronto ad aggredire ma quando mi trovai a un metro da lui, una voce flebile mi raggiunse chiamandomi per nome: «Antonio, Antonio, sei tu?». Era lui, ero davvero io, era la voce dell’amore e del perdono che ci ha unito le mani affinché io lo aiutassi nelle fatiche e nelle sofferenze della sua malattia. Ho capito che io ero diverso, che ero migliore degli uomini che eravamo stati. Così ci siamo salutati e non gli ho nemmeno chiesto a Di Benedetto perché lo avesse ucciso mio fratello. Solo dopo alcuni giorni, qualcuno si accorse che fra me e Di Benedetto c’era un divieto d’incontro e lo trasferirono a Opera, dove mi trovo anch’io dal 2019, pur in una sezione diversa dalla sua e qui oggi chiedo perdono per lui, ché mi provoca dolore vederlo soffrire e in lui ritrovo mio fratello morente. In lui ritrovo mio fratello.
La vita prosegue oltre gli strappi e come un’esperta ricamatrice sutura le ferite. Io aspetto dalle mie Parche, tessitrici della tela che mi resta, il dono per il ricamo mio più grande, intreccio di dolore e rimpianto, racconto di ciò che è stato e speranza del presente, aspetto un filo per disegnare la possibilità di tornare a esistere. Quel filo si chiama speranza.
*Ergastolano detenuto a Opera