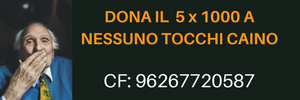12 Novembre 2023 :
Antonio Coniglio su L’Unità del 12 novembre 2023
Nel 1784, Immanuel Kant chiosò che “l’illuminismo è l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità che egli deve imputare a se stesso”. Qualche anno dopo, egli stesso ammonì ne “La critica della ragion pratica”: «Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo.» Sono passati oltre duecento anni da allora e non ci è dato sapere come il filosofo tedesco avrebbe commentato la storia di Susan: quella detenuta che si è lasciata morire di fame, a Torino, nella smania umana troppo umana di vedere – pensiamo un po’, fors’anche per un attimo – il figlioletto di quattro anni. Non certamente un suicidio stoico – l’atto conclusivo fiero del compito riservatoci dalla vita – ma l’autoeliminazione disgraziata e disperata di chi non coglie più un barlume di senso nell’essere in questo mondo.
Ve ne sono decine e decine, di suicidi, ogni anno nelle carceri italiane e fanno invero più morti della pena di morte negli Stati Uniti. Non ci è dato sapere come Kant avrebbe commentato la storia di questa “istituzione totale” contemporanea che si chiama carcere, la quale tratta l’uomo come mezzo, schiavo, instrumentum vocale, generando solo malattia, infermità, infine tortura elevata a sistema. E non ci è dato neanche conoscere come il pensatore di Königsberg avrebbe riflettuto, qualche secolo dopo, su questo paradosso infame, sulla beffa dell’età dei lumi la quale inventò il carcere nell’anelito spasmodico di superare la pena di morte. Pensiamoci un po’: si è superato un mezzo mortifero per crearne un altro tragicamente esiziale che, avverte Sergio D’Elia, ha ricompreso in sé quanto i tempi della storia erano riusciti evidentemente a scacciare: un manicomio, un lazzaretto, un calvario, un patibolo.
Le origini delle parole non tradiscono e quella “carcere” deriva dal latino “coerceo”: punire, castigare, costringere all’obbedienza. Forse è figlia pure dell’aramaico “carcar” – tumulare, sotterrare – a guisa di Giuseppe che, nel dettato biblico, venne calato in un pozzo. Proprio l’odierno penitenziario, l’istituto di pena che nasce ontologicamente per arrecare sofferenza, per seppellire uomini e cose. Ma chi si vuol “rieducare”? Invero un concetto ripugnante, una delle tesi del totalitarismo. I Soviet, tra gli altri, si erano inventati i “campi di lavoro correttivi” in cui si perdeva ogni giorno la vita, esalando sempre l’ultimo respiro. Le parole, in fondo, possono pure irridere se stesse e non è un caso che i Padri Costituenti dovettero aggiungere quel “tendere” all’art. 27 della Costituzione.
Nell’antichità, nel mondo classico, il carcere non esisteva. Perché nei “carceres” del circo romano, al massimo, erano trattenuti i carri prima della partenza. Proprio così: carri, bighe, non uomini. I classici conoscevano, non il carcere, ma la prigione. Prigione deriva dal latino “prehensio”: prendere, afferrare. Ti prendo, ti afferro e ti porto in luogo distinto dalla società perché sei pericoloso. Per un tempo determinato e senza alcuna intenzione punitiva. Starai lì, solo fino a quando sarai portatore di insidie e pericoli per gli altri, per il tempo limitatissimo del tuo “raffreddamento”. La prigione ha uno scopo preventivo, non punitivo. Non vuole rieducare alcuno. Non si pone questa missione divina, che gli uomini non dovrebbero neanche immaginare. Chi può rieducare chi?
Nella prigione romana, i prigionieri erano protetti da un semplice vestibolo, nel quale avevano finanche la libertà di incontrare parenti e amici. Un vestibolo, un passaggio, appunto. Era una “maison d'arrêt”, una casa di arresto. Sembra di risentire le liriche de “La ginestra” leopardiana, i richiami al secolo dei lumi: “Qui mira e qui ti specchia secol superbo e sciocco, che il calle insino allora dal risorto pensier segnato innanti abbandonasti, e volti indietro i passi del ritornar ti vanti e proceder li chiami”. Proprio così: abbiamo pensato di superare la pena di morte, specchiandoci nella “terribilità” di qualcosa di egualmente terrificante: il carcere.
Se crediamo davvero nella sicurezza sociale, ritorniamo indietro, aboliamo il “carcere” e sostituiamolo con le “prigioni”. Pensiamo di sorvegliare, non di punire. “Sapere aude”: osa esser saggio: abbi il coraggio di conoscere. Non era forse questo il motto dell’illuminismo che abbiamo imparato sui libri di scuola? Scegliamo illuministi di esserlo davvero. Coltiviamo il coraggio di aprire le porte del carcere, per conoscere il degrado, l’indegnità di quello che abbiamo partorito! Conoscere per superare. Conoscere per vergognarci! Per uscire da uno stato di minorità turpe che tratta gli uomini come mezzi, una menomazione culturale e civile che dobbiamo imputare a noi stessi. Che non illumina, ci consegna alle tenebre. Ma “in principio era il logos”. E allora… “Sia la luce”.