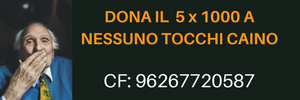28 Novembre 2025 :
“L’architetto della prigione è il primo esecutore della pena. Egli è il primo artefice dello strumento del supplizio”, sosteneva l’Ispettore generale delle carceri francesi Louis Mathurin Moreau-Christophe già nel 1838. I “luoghi della pena” è un capitolo dell’ultimo libro di Nessuno tocchi Caino “Non giudicare!”. Sarà anche un punto all’ordine del giorno del Congresso, il 18, 19 e 20 dicembre a Milano presso il Teatro Puntozero del Carcere Beccaria.
Cesare Burdese* su l’Unità del 28 novembre 2025
Elisabetta Zamparutti e Sergio D’Elia li conosco dal 2022, Rita Bernardini l’ho conosciuta nel 2013 in Commissione ministeriale istituita dopo la sentenza “Torreggiani”. Da decenni entro in carcere, per lo più per ragioni professionali. Con Nessuno tocchi Caino la cosa è diventata sistematica e qualcosa di diverso, consentendomi di conoscere aspetti per me altrimenti impossibili da cogliere.
Non ho ruolo né titolo di farmi carico delle istanze dei detenuti che, attraverso le sbarre dei pesanti cancelli, mi chiedono aiuto. Questo compito spetta al direttivo dell'Associazione, che ogni volta domanda, ascolta, illustra e spiega e dopo denuncia all’autorità competente. Per questo io converso con i detenuti in modo da evitare di creare in essi false aspettative, possibilmente su argomenti della loro esistenza, fuori dalla condizione detentiva, illudendomi così di alleviare per un attimo una condizione penosa. Dai “detenenti” personalmente apprendo le loro problematiche professionali e rivendicazioni, scoprendone valori e qualità.
Entro in carcere con metro e taccuino, misuro le celle per verificarne la superficie (i muri sfiorati dal metro mi raccontano…), schizzo ciò che più mi colpisce e suggestiona in quello che vedo. Fuori scrivo dei “muri” appena veduti e delle loro istanze, intrecciate con quelle delle varie umanità presenti; il quotidiano L’Unità mi pubblica. Quei “muri”, violando bisogni e diritti, denunciano l’impellenza di dare dignità e umanità al carcere.
A prescindere dalle epoche storiche di appartenenza, le carceri che visito, come peraltro tutte le restanti, palesano indistintamente gli stessi limiti, a detrimento della salute fisica e del benessere mentale degli occupanti: sovraffollamento, ventilazione insufficiente, visuali impedite, scarsa illuminazione naturale, rumore costante, igiene carente, fatiscenza e degrado, mancanza di verde, ecc., in una parola, totale disumanità.
A questo si aggiunge una configurazione spaziale limitata, più improntata alla sicurezza che alla riabilitazione del condannato, funzione peraltro questa che da numerosi decenni, in Occidente, è andata in crisi. Circostanze queste che rendono la quotidianità detentiva e lavorativa in carcere indecente e improduttiva, in uno stato di ozio forzato per i detenuti e precarietà per i “detenenti”, in luoghi che sembrano destinati a cose e non a persone. Tutto ciò a discapito delle finalità costituzionali della pena, in un gioco perverso di rimpallo di responsabilità.
Ogni volta rifletto sulla missione etica e politica che la riforma dell’Ordinamento Penitenziario da cinquant’anni ha attribuito al carcere quale strumento di trasformazione dell’individuo. Le carceri che visito sono però sempre altro, luoghi di afflizione che confliggono con la visione prettamente ideologica e astratta della rieducazione/risocializzazione. Una condizione che sembra irrisolvibile, viste la natura della detenzione e la sua funzione neutralizzante, la complessità dell’umanità presente e l’immobilismo strutturale della pubblica amministrazione in generale che tende a lasciare le cose come stanno.
Solo se guidato dall’alto e accompagnato dal basso un cambiamento può avere successo, mai in assenza di volontà politica e conseguentemente di risorse economiche e umane. L’architettura non può redimere ciò che la politica non vuole cambiare, sostituendosi a essa per risolvere contraddizioni sociali profonde. Resta legittimo il fatto che essa possa scendere in campo per cercare di alleviare un malessere materiale ed esistenziale in essere.
Le carceri che in questi anni ho visitato, rappresentano la negazione di un sogno ideologico che, pur fallendo, continua a interrogarci sulla relazione tra spazio, potere e libertà. L’auspicio, purtroppo sovrastato dall’illusione, è che l’orologio del progresso incominci a segnare le ore anche per l’esecuzione penale e la progettazione dei suoi luoghi, magari prospettando non un carcere migliore, ma qualcosa di meglio del carcere.
* Architetto