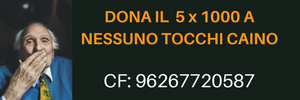22 Novembre 2025 :
L’opera di misericordia corporale di “visitare i carcerati” e quella di “curare gli ammalati”, hanno sempre connotato l’azione di Nessuno tocchi Caino. Innanzitutto nei luoghi detti di privazione della libertà, ma che spesso sono di privazione di molto altro: affetti, salute, la stessa vita. Ne parleremo al Congresso di Nessuno tocchi Caino, il 18, 19 e 20 dicembre a Milano presso il Teatro Puntozero del Carcere Beccaria.
Chiara Lenzi su l’Unità del 22 novembre 2025
“Dopo gli articoli de La Stampa il rampollo della Roma bene Costacurta è finito in manette.” Così rivendica il giornale, dopo che Francesca Fagnani, in una lunga intervista su Sigfrido Ranucci, aveva deciso di citare anche Matteo che nulla ovviamente ha a che vedere con quella vicenda, parlando del suo come un caso di “impunità” e insinuando che invece di stare in carcere era in una “clinica di lusso”. Questa narrazione è stata ripresa da altre testate e nel giro di poche ore mio marito è stato portato a Regina Coeli.
Quando è accaduto che il diritto alla cura per un detenuto è visto come un privilegio? O peggio: quando abbiamo accettato che un detenuto debba per forza soffrire per placare la sete di giustizia collettiva? È diventato normale credere che un detenuto non abbia più diritto alla dignità, alla salute, al rispetto. Come se la sofferenza altrui fosse uno spettacolo utile a sfogare la rabbia di chi guarda da fuori. Ma nessuno si chiede mai quanto davvero una persona possa soffrire.
Matteo alla prima anca ha avuto una necrosi, uno stato che comporta dolori atroci, perdita di mobilità e un lento, inesorabile peggioramento. Si è sottoposto a due interventi complessi – non di “routine” come scrive il giornale – e la riabilitazione era parte integrante del percorso indicato dai sanitari. Curarsi, per lui, non è mai stato un privilegio: era una necessità. Si è preferito costruire un racconto di “favori” e “lusso”, ignorando la realtà più semplice: Matteo ha solo usufruito del diritto, riconosciuto da referti e perizie, sottoscritte da medici nominati dai Giudici, di essere curato in una struttura idonea, come ogni cittadino dovrebbe poter fare.
La Fagnani, nella sua intervista, si chiede se un altro detenuto senza disponibilità economiche avrebbe avuto lo stesso trattamento. Invece di denunciare la carenza di assistenza sanitaria nelle carceri, la mancanza di personale, l’impossibilità per il sistema di garantire cure adeguate, ha preferito accanirsi contro Matteo. Il suo percorso riabilitativo richiede anche una piscina terapeutica, non disponibile nelle carceri, dove si curano malati; invece, in maniera allusiva, negli articoli è stata richiamata quasi fosse utilizzata per svago. Mio marito, al Nomentana Hospital, ci stava perché né il DAP né Regina Coeli hanno individuato una struttura per consentirgli tre sedute a settimana.
Si scrive di “impunità” ma si tace l’ingiustizia più grande: impedirgli di guarire. Si parla di “clinica di lusso” e si ignora volutamente che il Nomentana Hospital è una struttura pubblica convenzionata. I cosiddetti “giardini all’inglese” non sono mai esistiti, e il richiamo fatto negli articoli, come se lui ci potesse passeggiare liberamente, quasi fosse in vacanza, rispetto alla situazione di un detenuto che è in terapia per poter riprendere a camminare, si commenta da solo. E così, invece di lasciar proseguire una cura a un detenuto malato, di fronte al clamore della stampa e contro il parere dei medici, hanno scelto di interrompere tutto, perché da quando è tornato a Regina Coeli il programma terapeutico non è stato rispettato.
Oggi Matteo rischia di regredire nel suo processo di riabilitazione. Si insinua, si distorce, si alimenta la rabbia della gente. E mentre le parole corrono, la sofferenza resta, reale, quotidiana. Per mio marito ogni movimento è dolore, ogni notte è una sfida. I referti parlano chiaro: necrosi ossea, doppia protesi d’anca, patologie articolari. Tutto riconosciuto e certificato ma le carte non fanno notizia, il dolore non fa audience. È più semplice dipingerlo come uno che “sfugge alla giustizia” piuttosto che una persona ancora in attesa di sentenza definitiva, che non solo lotta per la sua innocenza ma anche, solo, per restare in piedi e non diventare invalido a vita.
E allora mi chiedo: cos’è diventato il giornalismo? Un tribunale parallelo dove si decide chi merita umanità e chi no? Perché la vittoria, oggi, sembra essere solo quella di averlo fatto tornare in carcere, e nessuno che si chieda se riesca a camminare, se provi dolore, se stia peggiorando. Ma non c’è vittoria nella sofferenza di un uomo. Non c’è soddisfazione nel dolore di chi già paga. Matteo non chiede favoritismi, chiede solo di poter guarire. Io, come moglie, chiedo solo che si torni a guardare le persone, non le etichette. Perché dietro ogni nome c’è una storia, una vita, una famiglia. E nessuna storia merita di essere trasformata in un titolo crudele.