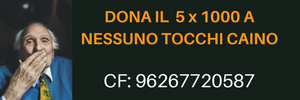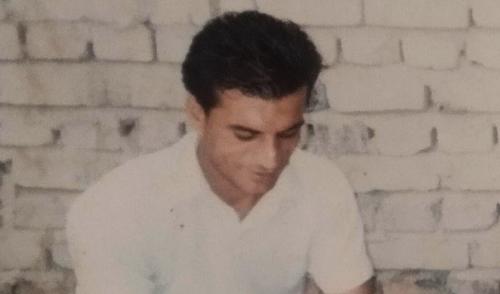11 Ottobre 2025 :
Andreana Esposito su l’Unità dell’11 ottobre 2025
Con una decisione che segna una ulteriore tappa nel percorso di progressivo affinamento degli standard di legalità convenzionale, Strasburgo torna a occuparsi delle misure di prevenzione patrimoniali italiane. La sentenza Isaia e altri c. Italia (25 settembre 2025), ha accertato la violazione dell’art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, ravvisando un’interferenza sproporzionata nel diritto di proprietà dei ricorrenti.
Il caso, avviato a Palermo nel 2018, riguardava il sequestro di beni ai sensi del Codice antimafia del 2011, che consente l’ablazione dei patrimoni sproporzionati rispetto ai redditi leciti. La pericolosità del proposto, fondata su condanne per reati predatori tra gli anni Ottanta e Novanta, era però remota: gli acquisti risalivano al 2010, 2016 e 2018, e le autorità avevano ipotizzato reinvestimenti di vecchi proventi illeciti.
Ed è qui che interviene la Corte EDU che non contesta la misura, ritenuta compatibile con la Convenzione, ma richiama l’Italia al rispetto delle proprie regole: la confisca deve mantenere una correlazione temporale con il periodo di effettiva pericolosità. Non basta la sproporzione tra redditi e patrimonio né ipotizzare reinvestimenti non provati: servono elementi concreti che colleghino i beni ai reati commessi.
L’operazione della Corte non è demolitoria, ma di cesello. La Corte non smantella il sistema, ma chiede rigore nell’applicazione. È la stessa logica che, in altri settori, l’ha portata a sottolineare i limiti di misure preventive troppo generiche (De Tommaso 2017) o a esigere rigorosi standard di prova nei casi bulgari di confisca senza condanna (Todorov, Yordanov). L’idea di fondo è che la lotta alla criminalità organizzata e alla ricchezza ingiustificata rimane legittima, anzi necessaria, ma non può tradursi in automatismi che scardinano la certezza del diritto.
La sentenza Isaia si colloca quindi nel solco di una giurisprudenza che non guarda con sfavore alle politiche di prevenzione patrimoniale, ma ne rafforza i contrappesi. Non dà indicazioni di cambiamento al legislatore. Indica, al contrario, alle autorità giudiziarie la strada di garanzie da seguire.
Alcuni giudici non hanno condiviso la decisione. Il giudice Sabato ha difeso le valutazioni dei tribunali italiani, ma il tono della sua dissenting opinion, incline a vedere nella sentenza una minaccia al sistema, convince poco. Egli equivoca sulla portata della sentenza che non demolisce l’impianto preventivo ma, al contrario, ponendosi nel solco di una lenta e talvolta timida opera di cesello, lo preserva perché dimostra che può essere collocato nella legalità convenzionale.
La via indicata è quella di recuperare e reindirizzare istituti che restano importanti nel contrasto alla criminalità organizzata. Ciò non significa, però, che la confisca debba mantenere la centralità che oggi occupa: essa, pur mantenuta come strumento di contrasto, può e deve essere ricondotta a un ruolo meramente residuale e di extrema ratio, accanto ad altri strumenti di prevenzione più equilibrati e coerenti con il bilanciamento tra efficacia e garanzie. Ed è questo il monito principale che i giudici europei rivolgono all’Italia: privilegiare una politica della prevenzione più sofisticata, meno centrata sull’ablazione patrimoniale, più attenta al bilanciamento tra interessi collettivi e diritti individuali. Una politica che si avvale della confisca quando serve davvero, ma che sa anche percorrere vie alternative, fondate su controlli, incentivi e percorsi di responsabilizzazione.
Non è necessario “colorare di penalità” la confisca di prevenzione per ridurne il carico afflittivo: è sufficiente ricondurla a una autentica funzione preventiva, fondata su un ragionevole equilibrio tra sicurezza e libertà e assegnarle un ruolo ancillare, privilegiando invece gli altri strumenti che il sistema di prevenzione italiano ha progressivamente
sviluppato. Meccanismi capaci di coniugare legalità e garanzie: dal controllo giudiziario delle imprese alla loro amministrazione temporanea, da modelli premiali di collaborazione fino a percorsi di recupero aziendale che mirano a bonificare dall’interno realtà economiche compromesse.
Se la confisca di prevenzione ha rappresentato un presidio fondamentale contro le mafie e l’accumulazione criminale, oggi il vero banco di prova è la sua capacità di convivere con le garanzie della Convenzione. La Corte EDU ha alzato l’asticella, ma non ha chiuso la porta: ha ricordato che legalità e prevenzione non sono incompatibili, purché l’una non travolga l’altra.