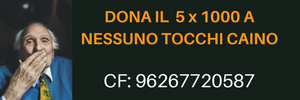24 Gennaio 2026 :
Tonino D’Angelo su l’Unità del 24 gennaio 2026
Ho un figlio che si chiama Francesco. Da quasi sei anni si trova in un reparto psichiatrico del carcere di Reggio Emilia che, senza offesa per nessuno, potrei chiamare ancora OPG. Perché, anche se formalmente non esistono più, nella realtà quotidiana stiamo tornando a quel modello: un luogo di custodia più che di cura. Parlo non solo come padre, ma anche come uomo delle istituzioni. Per quarant’anni ho diretto un servizio per le dipendenze patologiche e sono stato responsabile della sanità penitenziaria.
Dico una cosa che può suonare provocatoria ma non lo è: il giubileo c’è già. C’è un’amnistia, c’è un indulto, ma di natura diversa da quella che appare nelle leggi. È un giubileo istituzionale, un’autoassoluzione generalizzata che le istituzioni concedono a sé stesse. Ogni volta che denunciamo violazioni delle norme, delle sentenze, dei diritti fondamentali e nulla cambia, si compie un atto implicito di amnistia: chi governa e chi gestisce si perdona da solo. È come se vivessimo in una continua sospensione della responsabilità. Ecco perché non voglio più amnistie o indulti solo per i detenuti: voglio un’amnistia sociale e istituzionale, un cambiamento culturale in cui lo Stato si assuma la propria parte di colpa. Perché quando un ministro come Nordio lancia proclami temerari sulla giustizia o sull’ergastolo, crea un grave scompiglio istituzionale e distoglie lo sguardo dai problemi reali: le carceri che esplodono, la salute mentale abbandonata, la dignità delle persone dimenticate.
Oggi stiamo chiedendo una liberazione anticipata speciale, ma anche e soprattutto la chiusura definitiva di questo sistema che riproduce vecchi manicomi giudiziari sotto nuovi nomi. Non esiste più l’OPG, ma si sta costruendo un “ospedale psichiatrico giudiziario diffuso”, che rinchiude e segrega chi avrebbe invece bisogno di essere curato. Io stesso sono coordinatore del gruppo “Salute mentale nelle carceri” della Consulta regionale dell’Emilia-Romagna, e con Rita, Sergio ed Elisabetta stiamo cercando strade comuni per superare questo sistema. In questo, Nessuno tocchi Caino rappresenta una voce insostituibile: non solo denuncia le ingiustizie, ma costruisce rapporti, ricuce legami, difende la dignità umana. Eppure, fuori, qualcuno la deride o la criminalizza, come se parlare con “l’altro lato” fosse tradimento. Ma chi opera nel rispetto dei bisogni della popolazione carceraria – e delle loro famiglie – non si piega a logiche di comodo: compie un atto di civiltà.
Le famiglie dei detenuti meritano parole di verità. Ogni settimana compiono un pellegrinaggio silenzioso verso il “santuario del carcere”. Sono famiglie incarcerate anch’esse, che vivono la pena attraverso l’attesa, la vergogna, la fatica, e spesso senza alcun sostegno. E quasi sempre sono donne: madri, sorelle, mogli, figlie, spesso sole, invisibili sia alle istituzioni sia agli enti locali. Nessuno pensa a loro, ma sono loro a portare il peso più doloroso e duraturo di questa condizione. Il carcere non finisce ai cancelli: continua nelle case, negli sguardi, nei silenzi.
C’è una parola che sento spesso risuonare nelle sale colloqui, a voce alta o bassa, ma sempre sincera: pietà. Una parola antica, quasi dimenticata, ma essenziale. La pietà è ciò che manca alla nostra società, che si è fatta dura, selettiva, impaurita. Eppure, senza pietà, non c’è cura possibile. Non c’è comunità. Perché nessuno deve essere escluso dalle cure, neppure chi ha sbagliato o chi ha sofferto. Il carcere fa parte del territorio, della comunità cittadina, e deve ritrovare un ruolo umano e sociale. Credo che anche le vittime, nel loro intimo, chiedano pietà. Perché quando trasformiamo le vittime in simboli di una giustizia sommaria, generiamo altre vittime, altri carnefici. La giustizia senza compassione diventa vendetta, e la vendetta è l’opposto della civiltà.
Serve una rivoluzione gentile, che metta al centro l’empatia, la misericordia e la riconciliazione. Papa Francesco ce lo ha ricordato con forza: il giubileo non è solo un rito religioso, ma un tempo per riaprire le porte del cuore. Mio figlio, che in carcere si fa chiamare “Barabbas”, mi ha detto una frase che non dimenticherò: “Hanno salvato Barabba per condannare un innocente.” Da quel pensiero ho capito quanto ancora dobbiamo imparare sul perdono, sulla dignità e sulla libertà. E allora sogno un futuro senza nemici, dove la fraternità non è utopia ma scelta civile. Ecco, credo che questa sia la strada. Capire, tutti insieme, che questa non è una battaglia di pochi, ma la battaglia di un Paese intero che vuole ritrovare sé stesso, la propria pietà e la propria dignità.