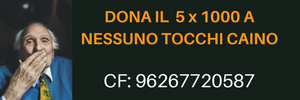05 Novembre 2024 :
10/10/2024
A 2 anni dall'emanazione della Legge sulla Giustizia Riparativa, la cosiddetta Legge Cartabia o Riforma Cartabia, Nessuno tocchi Caino pubblica 2 interviste ad esperte del settore: Patrizia Patrizi e Gemma Varona. In alcuni passaggi la terminologia può essere molto specifica, sono state aggiunte note a piè di pagina, ma nel complesso la condizione attuale della Giustizia Riparativa in Italia, e non solo, è meticolosamente delineata.
La professoressa Patrizia Patrizi, Ordinaria di Psicologia giuridica e pratiche di giustizia riparativa all’Università di Sassari, è psicoterapeuta e mediatrice esperta in giustizia riparativa con qualifica di formatrice del Ministero della Giustizia. Past President dell’European Forum for Restorative Justice[1], e membro del Consiglio Direttivo di NtC, è una dei massimi esponenti della Giustizia Riparativa in Europa.
Ha appena pubblicato la seconda edizione del libro, a sua cura, “La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità”[2].
Il volume dedica uno specifico capitolo alla Disciplina organica[3] della Giustizia Riparativa, ma la norma costituisce oggetto di riflessione anche in altre parti del volume che ne argomentano alcuni aspetti attualmente critici.
Abbiamo letto il suo libro, e abbiamo notato i timori suoi e di alcuni suoi coautori sulla visione penalistica che rischia di permeare di sé l’iter di un programma riparativo. Davvero c’è il rischio che sia la giustizia “formale” a inglobare quella “riparativa”, mentre tutti speravano che fosse quella riparativa a trasformare quella “formale”, il semplice concetto retributivo di punire e carcerare?
Non parlerei di rischio, ma di evidenza. Non succede solo in Italia: ovunque c’è un gap tra le teorie di progresso sociale della giustizia riparativa, e i (legittimi) interessi degli stati a ridurre la durata dei processi, e a incidere sulla recidiva. Tali obiettivi sono di grande rilevanza anche per le persone coinvolte in un processo e, più in generale, per la comunità. È però fondamentale che giustizia riparativa e sistema giudiziario, mantengano la loro indipendenza sotto il profilo valoriale e organizzativo. E, rispetto a questo, ritengo che la Disciplina organica abbia travalicato il senso del suo essere norma primaria: è entrata troppo nel dettaglio, persino di come devono svolgersi gli incontri, di quanti mediatori, la loro formazione, ecc.
Al sistema giuridico interessa deflazionare i tribunali e ridurre la recidiva? Bene, la giustizia riparativa, rispettando tutti i valori e principi che la caratterizzano, può forse incidere relativamente rispetto all’obiettivo deflativo, ma può avere anche risvolti nella riduzione della recidiva, soprattutto nel rispondere ai bisogni della vittima di avere voce e risposte, e rispetto alla possibilità per la persona indicata come autrice dell’offesa di sentirsi responsabile nei confronti di chi ha subito. Noi continueremo a fare quello che sappiamo fare bene, a lavorare con le persone, con le relazioni. Il lavoro sui grandi numeri è un’altra cosa. Anche se, sui grandi numeri e nel tempo, la giustizia riparativa può incidere, attraverso una migliore soddisfazione di vittime e di autori, come evidenziato dai dati di ricerca provenienti dai paesi in cui la giustizia riparativa è attiva da più tempo.
Nel rapporto fra i due sistemi (penale e riparativo) una questione, che si sta presentando all’attuale dibattito, è per esempio quella della “strumentalità” con la quale la persona indicata come autore dell'offesa potrebbe decidere, chiedere di partecipare a un programma di giustizia riparativa. Personalmente ritengo che si tratti di un falso problema. L’eventuale strumentalità, e sottolineo “eventuale”, non può essere attribuita alla persona, ma ai criteri dello stesso sistema penale che potrà valutare la partecipazione al programma di giustizia riparativa e il suo esito, sia come accordo di riparazione che come fedeltà all’accordo stesso, rispetto alle misure previste in sede processuale e di esecuzione di pena. Ma questo meccanismo non ritengo che possa essere attribuito alla persona, piuttosto alle logiche del sistema nel quale la persona si trova. Riterremmo forse strumentale allo stipendio o a un avanzamento di carriera un lavoro svolto correttamente e, magari, con passione?
Può approfondire questo “problema della strumentalità”?
Come ho già detto, sul concetto di strumentalità sono fortemente critica, perché se sono dentro un sistema penale, e dentro un processo nel quale devo dimostrare la mia innocenza, perché tendenzialmente è quello che tentiamo di fare quando siamo colpevoli di qualunque azione, anche non di rilevanza penale, come potrebbe non esserci strumentalità? Tutto è strumentale nel contesto penale, ma inevitabilmente direi, così come è difficile per la vittima accettare un incontro o addirittura richiederlo. A meno che non le sia stato spiegato prima e bene cosa significa la giustizia riparativa, a meno che non abbia in quel momento un bisogno che è stato intercettato, dice: “io devo partecipare a questo programma per far del bene all'autore del reato? Ma neanche per idea!”. Un tasso di strumentalità e di difficoltà è ineliminabile, e qui stanno l’abilità e l’esperienza del mediatore/facilitatore.
L'importante è che ci si lavori bene in modo che, per esempio, tutti i giudici, tutti gli avvocati sappiano bene di che si tratta, conoscano davvero la giustizia riparativa, ne conoscano/riconoscano la dimensione umana-relazionale, i valori, i principi, e la propongano con cognizione di causa (vorrei dire credendoci davvero, con sincerità).
Restando sulla questione del sistema penale che ingloba la giustizia riparativa, è probabile che all’inizio alcuni avvocati la guarderanno con sospetto (questo sta avvenendo) o rimarcheranno ai loro clienti solo gli effetti “giuridicamente convenienti” … Ricordo che qualcosa di simile è successo quando, nel 1988, nelle disposizioni sul processo penale minorile (DPR 448/88), è stata introdotta per la prima volta la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28). All’epoca io lavoravo in ambito minorile. Il DPR prevede che se l’esito della messa alla prova è positivo si estingua il reato. Soprattutto in fase di prima applicazione, gli avvocati suggerivano ai minorenni di partecipare, anche se non si riconoscevano responsabili: questo è evidentemente un uso strumentale che nulla ha a che fare con gli obiettivi della messa alla prova, che sono responsabilizzazione, sviluppo di orientamenti prosociali, crescita personale. Psicologicamente ma soprattutto nell’ottica restorative, è un tema rilevante.
La strumentalità è l’altra faccia della responsabilità. È scritto nella pagina del sito ufficiale del Ministero di Giustizia dedicata alla GR “la Giustizia riparativa introducendo la dimensione della responsabilità verso l’altro offre una grande opportunità in ambito trattamentale” … come dice lei, professoressa, sarà molto raro che una persona al centro di un processo penale riesca ad essere davvero sincera, ed evitare atteggiamenti strumentali, anche inconsapevolmente. Ma voi conoscete bene l’argomento sin dai tempi in cui le prime pratiche riparative sono state introdotte in ambito minorile…
Però, nel minorile, riconoscersi la responsabilità, menzionando ancora l'articolo 28, significa che io sento, prendo coscienza del danno che ho causato o comunque che ho agito in un certo modo.
Nel settore delle persone adulte, la questione è più complicata. Nel minorile c'è sempre l'attenzione alla persona minorenne, alla crescita della personalità, al suo sviluppo; quindi, della stessa responsabilità si riconosce la dimensione evolutiva: a partire dal grado di responsabilità attivo, come sviluppare le variabili psicologiche che possano sostenerne lo sviluppo? Di qui la predisposizione di programmi di messa alla prova che possano favorire apprendimento di responsabilità.
Come dice la professoressa Gemma Varona, nelle persone già condannate c’è più tempo per lavorare, e forse un pizzico di rassegnazione in più che spinge verso la sincerità… se capiamo bene, i minorenni prima di essere messi alla prova venivano condannati, nel senso che comunque qualcuno deve averli ritenuti colpevoli… la legge per gli adulti invece prevede che si possa accedere alla giustizia riparativa già prima del processo…
Per la verità no, non venivano “automaticamente” condannati. Diciamo più correttamente che, aldilà del perdono giudiziale, non esistevano istituti atti a ridurre la presenza del sistema penale nella vita di un adolescente. Quella a cui fa riferimento lei, probabilmente, è la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale: quella sì interveniva e interviene dopo la condanna (come nel settore adulti). La sospensione del processo con messa alla prova ha un altro significato, per questo, interrompe il processo per avviare un percorso di crescita e responsabilizzazione, riducendo i rischi di istituzionalizzazione e stigmatizzazione (l’estinzione del reato per esito positivo della prova è espressione massima del principio della de-stigmatizzazione).
Tornando alla giustizia riparativa, la norma parla di “persona indicata come autore dell'offesa”, e tale scelta tiene correttamente conto del principio della presunzione di non colpevolezza, e questo è corretto. Ma la fase processuale è particolarmente delicata: se accedo alla giustizia riparativa, forse sto ammettendo di essere colpevole? se non ci vado, forse non rispondo a questa proposta, quindi come vengo valutato? Questo mi sembra un aspetto particolarmente delicato e critico.
Quando diciamo che il sistema penale si è appropriato della giustizia riparativa (richiamando una nota affermazione di H. Zehr, padre della restorative justice), è che per certi versi l'ha ricondotta alle proprie regole, perché l'assunzione di responsabilità, il riconoscersi responsabile durante il processo in un sistema penale tradizionale, è scoraggiato, e attenzione questo non vuol dire che un programma riparativo non possa andare benissimo con una persona che la responsabilità non se la riconosce, perché si prendono degli accordi e la vittima è soddisfatta, o forse durante il percorso l'autore si attiva particolarmente rispetto a quelle che sono le conseguenze causate, però questo è un linguaggio della giustizia riparativa, non è del sistema processuale penale.
Lei dice che il sistema penale tradizionale “scoraggia” l’assunzione di responsabilità… in realtà una confessione garantisce delle attenuanti, ma è vero che gli imputati, sapendo di poter contare anche su un processo d’Appello e uno di Cassazione, preferiscono tentare la roulette russa del processo: o tutto o niente, chi se ne importa di una leggera attenuante per la confessione, meglio non confessare…
Ed è per questo che i termini sono diversi e devono rimanere diversi. Per un magistrato si dice “confessione”, per chi sostiene la giustizia riparativa si dice “assunzione di responsabilità”, meglio ancora accountability (sentirsi responsabili delle conseguenze nei confronti di chi, quelle conseguenze le ha subite). Quindi, non è solo nei confronti della legge, qualcosa che molti percepiscono come astratta, ma nei confronti di chi ha subito e della comunità: persone.
Anche il concetto, di cui parla John Braithwaite, della vergogna reintegrativa, è di grande rilevanza. In realtà la vergogna reintegrativa riguarda entrambi, la vittima perché comunque un po' viene accusata (quando ho subito un furto nel mio appartamento, ricordo la prima cosa mi ha chiesto la vicina, “ma pure tu… oltre alle grate, hai le persiane di ferro: perché non le hai chiuse”). Sto parlando della colpa, la colpa che si trova la vittima perché deve sempre comunque aver fatto tutto giusto; e la vergogna reintegrativa dell'autore, che non è lo stigma, perché lo stigma impedisce anche di dispiacersi e vergognarsi, perché è talmente forte lo stigma, è talmente deleterio, traumatizzante, che ti accompagna in tutti i contesti, per avere un lavoro, i documenti, quello è puro stigma. La vergogna reintegrativa è quando di fronte alla persona, di fronte alla comunità ti senti così male e assumi anche di più quella responsabilità, ma anche la possibilità di reintegrarti, per esempio c'è un programma riparativo che mi pare si faccia anche in alcune parti d'Italia, di sicuro a Milano, nel carcere di Bollate, e non mi ricordo in quali altri luoghi. Mi riferisco ai Circles of Support and Accountability, è lì il valore del supporto e responsabilità, cioè ti chiedo responsabilità… ma al tempo stesso ti offro supporto. E i Circle di supporto e responsabilità sono strumento molto utile in termini di accountability, sono strutturati proprio per questo, il reinserimento attivo con il coinvolgimento della comunità, perché il reinserimento è una delle cose più difficili dopo che sei stato disinserito: è difficile per chi esce dal carcere, è difficile per le persone vicine, per la comunità.
E soprattutto ti viene chiesto di reinserirti, ma il modo devi trovartelo da solo, perché lo stato non ha mai creato strutture intermedie, sentieri per il reinserimento graduale...
Esatto, senza nessuna possibilità, con una comunità che a sua volta si difende, c'è la comunità che vuole solo vendetta e non vuole saperne del fatto che sei uscito dalla galera “troppo presto”. Noi dobbiamo lavorare sul reinserimento attivo, che coinvolga anche i componenti della comunità, perché non è soltanto una faccenda dell'autore del reato, della sua famiglia …riguarda tutte e tutti noi, la società e le istituzioni. Purtroppo, ancora oggi non è così…
Perché una comunità troppo ostile si danneggia da sola, perché, respingendo troppo brutalmente un piccolo criminale occasionale, lo indurrà a sentirsi senza alternative, e gradualmente, ma velocemente, si trasformerà in un criminale professionista. E questo è sicuramente un danno per tutti, anche per quelli che credono che sarebbe sufficiente costruire nuove carceri…
Già, perché se c'è la comunità ostile, se non trovi niente, se pensi che quello stigma dovrai portartelo per il resto della vita, le cose peggiorano per tutti. Questo, se è possibile, deve essere prevenuto. Per questo si lavora anche molto con le comunità, ci sono dei programmi molto interessanti. Il lavoro con comunità può essere definito di cura perché, in effetti, non si lavora solo per riparare le conseguenze di un singolo incidente, della singola “offesa” di un singolo “offender”, ma per supportare un processo di “guarigione” di più ampia portata, che possa essere ancora in atto quando qualcun altro danneggerà la comunità. In cosa consiste anche questa guarigione? Beh, anche in questo, nel fatto che fra i valori c'è proprio quello del supporto, della solidarietà e della responsabilità, quindi io ti supporto, tu assumi responsabilità, ma io ti supporto.
Come avviene il riconoscimento dei Centri? Come è avvenuto?
Attraverso una ricognizione dei servizi operanti e delle attività di giustizia riparativa che già si svolgono avviata dalle Conferenze Locali[4] con il coinvolgimento dei comuni, gli UEPE[5], gli USSM[6].
È sulla base di tale ricognizione (che dovrebbe essersi conclusa entro il 31 0ttobre) che verranno riconosciuti i Centri in regola con quanto previsto dalla norma e dai LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni dei Servizi per la Giustizia Riparativa[7], elaborati dalla Conferenza Nazionale[8]) e ne verranno istituiti nelle località sprovviste. Esisterà un solo centro per distretto di Corte d’Appello. Altri potranno sorgere, ma non saranno sostenuti dai fondi attualmente stanziati.
Non ho altre informazioni su questo punto. Potrebbe essere di certo più utile chiedere ad alcuni centri “storici” che ritengo abbiano maggiori conoscenze. Penso a quello del Trentino, quello di Torino, di Milano.
In altri luoghi - e qui si crea una nuova disparità tra nord, sud, centro, isole - non c'è niente, ci sono piccole associazioni che magari facevano qualcosa, quindi adesso se penso alla Sardegna si deve capire dove verranno istituiti i centri, tenendo presente che l’isola è grande, e gli spostamenti sono disagevoli, perché una persona di Oristano non è che va a Cagliari… si prevedono sedi distaccate. Le piccole associazioni del nostro territorio dovranno strutturarsi in maniera più stabile per soddisfare la normativa, serviranno fondi per attività che invece fino a oggi sono state quasi interamente gestite come volontariato sociale, o grazie a specifici finanziamenti, es. da parte di Cassa delle Ammende o di Enti Locali.
La legge Cartabia prevede 26 Centri per la Giustizia Riparativa, uno in ogni distretto di Corte d’Appello. La Sardegna ha il distretto a Cagliari, e una “sede distaccata” del distretto a Sassari, quindi, dovrebbe avere almeno questi due Centri, Cagliari e Sassari…
Lei ha citato Tempio Pausania, una cittadina della Gallura nei cui sobborghi nel 2012 è stato inaugurato il carcere di Nuchis, destinato ad accogliere detenuti in AS3[9], che ha preso il posto di un vecchio carcere ottocentesco con 50 posti. Oggi Nuchis ha 200 posti, 50 dei quali “riservati” ad ergastolani “ostativi”, cioè quelli esclusi da programmi di riabilitazione e reinserimento…
Sì, ed è proprio in questo luogo, che la legge vorrebbe “senza speranza” che da anni mandiamo avanti un programma dentro e fuori il carcere di alta sicurezza, che è quella pratica riparativa del circle tra comunità e autore di reato, quindi la vittima non c'è. Non c’è anche per un problema di lontananza: i detenuti per reati di criminalità organizzata non vengono quasi mai dal territorio circostante. Nel caso di Nuchis, c’è una questione di “isolamento geografico”: nel nord della Sardegna, lontani dal porto e dall’aeroporto di Olbia, lontani dall’aeroporto di Alghero… i detenuti di Nuchis vengono quasi tutti dal “continente”, dal Meridione… immagina una vittima che volesse prendere in esame l’ipotesi di partecipare a un programma riparativo, pensa solo al tempo e al denaro che le costerebbe venire a Nuchis…
Le vittime abitano lontano, e a volte le vittime nemmeno esistono, nel senso che la criminalità organizzata ha il suo business principale nel traffico di droga… chi è la vittima “individuale” di un membro di una associazione mafiosa o paramafiosa che importa stupefacenti?
Certo, le vittime, quando sono identificabili, spesso abitano lontano… dovremmo andare noi facilitatori e facilitatrici a trovare loro? Venire loro ad incontrare noi? E poi gli step successivi, gli incontri in carcere… quanto tempo, quante spese… ecco vedi, così possiamo finire con il discorso sui bisogni delle varie parti coinvolte in un dialogo riparativo… alcune situazioni presentano difficoltà logistiche quasi insormontabili, e questo crea disparità, a volte enormi disparità, al confronto con altre situazioni dove far incontrare le parti è molto più semplice… noi a Nuchis, è innegabile, scontiamo anche grosse difficoltà di questo tipo.
La politica di allontanare i detenuti considerati “pericolosi” dalle loro regioni viene motivata con “ragioni di sicurezza”, ed è fatta apposta per rendere loro più difficile tenere i contatti con i familiari, che potrebbero essere anelli di congiunzione con i complici. Questo però comporta difficoltà anche per gli avvocati, e come dice lei, anche per un eventuale percorso riparativo… insomma, la sicurezza viene fatta prevalere su qualsiasi altra considerazione. Per voi, che già dovete fare un lavoro difficile, tutto diventa così ancora più difficile…
Sì, noi seguiamo le vicende della Casa di Reclusione di Nuchis sin dal momento in cui è stata destinata all’alta sicurezza, e la comunità locale temeva che avrebbe sconvolto il circondario, con l’arrivo di criminali non solo dentro le mura, ma in qualche modo anche fuori. È da lì, da quel periodo che abbiamo iniziato a lavorare per “accorciare le distanze” con la comunità… e mentre affrontavamo, anche in qualità di università del territorio, di quel territorio, i timori della comunità locale, abbiamo iniziato quasi subito a poter lavorare anche con la comunità “ristretta”, e lì siamo stati coinvolti nei bisogni basici dei detenuti.
I detenuti soffrivano perché erano lontani dalle loro famiglie, dalla loro città, innestati in un’altra comunità che era fortemente arrabbiata per queste presenze e possibili infiltrazioni criminali; c'era malcontento in una comunità che non avrebbe voluto quel tipo di carcere. Abbiamo, quindi, avviato un lavoro che ha progressivamente assunto anche altre forme in funzione di bisogni e opportunità via via emergenti.
Coerentemente con quanto prevede la giustizia riparativa, il programma attivo a Nuchis è partito da un bisogno. Come già detto, la trasformazione dell’istituto in “alta sicurezza” aveva generato un diffuso senso di malessere nella comunità. Il programma è quindi nato per affrontare una sorta di conflitto sociale, di qui la sua tipicità che, a partire da incontri detenuti e operatori-comunità, progressivamente ha visto nascere sensibilizzazione presso le scuole (nel libro se ne parla in due capitoli) e l’istituzione di un Servizio riparativo. Il garante comunale delle persone private della libertà è stato istituito in una occasione unica nel suo genere: lo svolgimento di un Consiglio comunale proprio all’interno della CR. E, nelle premesse del documento istitutivo, contiene il riferimento alla giustizia riparativa. Ora Tempio Pausania è riconosciuta anche a livello internazionale come città riparativa. E, in quella città si svolgono molte iniziative ispirate ai valori della giustizia riparativa (cito fra tutte un progetto voluto dal Comune nell’ambito di una rete ANCI). Certo, perché la giustizia riparativa possa essere riconosciuta e diffondersi è necessaria la sensibilità delle istituzioni, il loro supporto! E a Tempio Pausania è stato così: a partire dalla prima direttrice dell’Istituto che ha fortemente voluto l’avvio del programma riparativo (in una conferenza indetta nel periodo di malessere, aveva chiamato a raccolta tutta la comunità e le istituzioni), alla Municipalità (dal Consiglio comunale in carcere, all’istituzione del Garante, al supporto alle attività anche nelle scuole, alla disponibilità costante verso ogni iniziativa del nostro Team delle pratiche di giustizia riparativa).
Tempio Pausania, la cittadina di cui Nuchis è un sobborgo, ha il record di essere stata la prima città italiana a dichiararsi “Città Riparativa”…
Esattamente, tra le poche città riparative, noi siamo la prima in Italia.
Considera che le città riparative sono percorsi in costruzione. Quasi tutte quelle che conosco non possono essere definite come Hull, in Inghilterra, la prima città denominata riparativa. Una vera città riparativa dovrebbe avere impostato tutti i servizi in quella chiave come Hull, però la città riparativa non è che la definisce una norma, è una città che progressivamente si organizza in chiave riparativa. E qui abbiamo il comune di Tempio Pausania che è particolarmente sensibile e attivo, che riconoscendo l'importanza della giustizia riparativa, per averne avuto esperienza diretta, favorisce lo sviluppo della giustizia riparativa in ogni luogo. Noi lavoriamo nelle scuole, con il carcere, con il comune abbiamo fatto vari incontri anche con la cittadinanza, è un processo in costruzione. Penso che nel capitolo dedicato del mio libro lo si intuisce; anche quando diciamo che abbiamo modificato il modello concettuale, perché procedendo modifichi anche le cose, in fondo è questo il lavoro di un intervento nel vivo della comunità, se lo vogliamo definire così.
Parlando sempre del suo lavoro, che abbiamo detto è stato davvero prolifico e in un carcere che ospita detenuti in regime di alta sicurezza, quindi dove ci sono anche i mafiosi, per esempio la Cartabia, nella legge, prevede che i programmi di giustizia riparativa possano essere applicati a tutti indifferentemente dalla tipologia di reato, quindi in teoria non esclude nessun reato, ma gli ostativi, il 41bis, possono veramente accedervi?
La disciplina organica non prevede preclusioni nell’accesso alla giustizia riparativa. Per “rimediare” a una previsione che forse sapeva troppo di apertura… è intervenuto il pensiero securitario del cosiddetto decreto carceri (D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito in L. 8 agosto 2024, n. 112), che modifica l’art. 41 bis, aggiungendo, con lettera f-bis, “l’esclusione dall’accesso ai programmi di giustizia riparativa”. Tale preclusione sembra non avere nulla a che vedere con le motivazioni alla base dell’art. 41-bis, la cui finalità è quella di evitare contatti con la criminalità organizzata. Quindi, quale è la motivazione alla base della lettera f-bis? Presunti contatti con la criminalità organizzata? Non fiducia nell’imparzialità dei mediatori? Sento di voler affermare che tale modifica rappresenta un grave attacco ai diritti del detenuto e della sua vittima, nonché alla deontologia e al rigore professionale di chi media.
Come attivista da decenni per la Restorative Justice però queste resistenze le avrà incontrate a qualsiasi livello, resistenze che sembrano non voler tener conto, per partito preso, degli effetti positivi a medio e lungo termine delle pratiche riparative. Tim Chapman ad esempio nel vostro libro riporta accurati dati scientifici su come l’approccio “restorative” produca risultati: vengono documentate riduzioni del 25% sulla recidiva, quindi un grosso vantaggio economico in termini di sistema penale e carcerario, ma soprattutto, documentati in maniera altrettanto inoppugnabile, alti indici di gradimento da parte delle vittime che hanno potuto accedere a programmi ben strutturati, e vantaggi psicologici rispetto alla “freddezza burocratica” dei sistemi penali tradizionali…
Se pensiamo ai benefici, alla base, c'è di sicuro quello di avere voce. Le persone hanno bisogno di parlare, hanno bisogno di dire il loro vissuto, la loro lettura di come sono andate le cose. Quindi soprattutto per la vittima, ma anche per l'autore, perché possiamo dire che sia vittima che autore sono “maltrattati” dal sistema penale: la vittima non è considerata, se non quando deve testimoniare; l'autore è incastrato perché gli viene, giustamente, chiesto di dire la verità, quindi di assumere responsabilità, di “incriminarsi”, per certi versi. Una sorta di paradosso, in pratica, almeno dal punto di vista psicologico, perché quella verità avrà come corrispettivo la pena.
La vittima, peraltro, va spesso incontro a un processo di doppia vittimizzazione. Proprio quando viene chiamata a testimoniare. Si deve attenere strettamente ai fatti, e affinché si attenga ai fatti, viene spesso sottoposta a un interrogatorio estenuante. In un contesto riparativo, invece, ha la possibilità di dire la propria verità, non solo “riferire fatti” … questo credo che sia un bisogno fondamentale della nostra esistenza. È lo stesso meccanismo che si crea in una terapia, in terapia io posso dire quello che sento, non sono censurata, io posso dire anche cose allucinanti perché sono quelle che sento, che mi opprimono, allora lì avere voce è fondamentale.
Per la vittima, è fondamentale poter chiedere, poter avere delle risposte. Anche per l'autore è importante poter avere voce, parlare di sé, dell’azione commessa, poter dire cosa è successo, come mai dal suo punto di vista: nel processo “non” può farlo, ma nel contesto della pratica riparativa non è giudicato, è l’azione a essere condannata. In quel contesto, e a partire dalle diverse narrazioni, insieme si può ricostruire una nuova narrazione orientata al futuro, a come ripristinare giustizia, proprio a partire dall’ingiustizia subita e agita. Entrambi hanno bisogno uno dell'altro.
La vittima ha anche bisogno di informazione (il suo poter fare domande, ottenere risposte). Sapere perché proprio a lei, sapere le ragioni, sapere se la persona che le ha fatto del male si è pentita. Anche sapere soltanto che forse quella persona vuole non ripetere quel reato, o anche sapere le condizioni di quella persona, le sue ragioni, che non giustificano, però sono delle ragioni che “mi fanno pensare che tu non ce l’avevi proprio con me”, come dire, ce l’avevi con me perché ce l’avevi con le donne, perché non lo so. Ci possono essere tante situazioni diverse, per esempio: perché sei entrato dentro casa mia? perché ti dovevi fare una dose? ma non ci hai proprio pensato al fatto che stavi violando il luogo in cui vivo e che, ora, io ho paura? Chi ha subito ha bisogno di avere informazioni e l'esperienza della giustizia riparativa è basata proprio sull'ascolto, con massimo rispetto della dignità umana. Il rispetto per la dignità umana è un valore fondamentale della giustizia riparativa. Ed è un valore fondamentale per entrambe le parti. Pensiamo all’autore: sì ho commesso il reato, ma io non corrispondo al mio reato, non sono il mio reato, stiamo parlando del danno, stiamo parlando delle conseguenze della mia azione, ma non di me come persona. Allo stesso modo la vittima, sì sono quella che magari non è stata capace di difendersi, ma io fondamentalmente ho subito questo, io continuo ad aver paura adesso… Ricordo quest'anno a lezione una ragazza che ha fatto un percorso meraviglioso perché fino alla fine continuava a dire: “No ma io quello non lo voglio incontrare, perché è entrato dentro casa mia, perché questa giustizia riparativa non la capisco”, alla fine delle lezioni aggiunge, “perché poi era una persona che conoscevo, ma non l’ho potuto dire, ma ho capito da tante cose che era stato lui, e vedo che continua a salutarmi quando ci incrociamo per strada”. Pensa a quella ragazza, pensa a quando si porta dietro… e in una terapia lo può dire alla sua terapeuta all'infinito, ma non ha risolto il problema… Lo risolverà forse quando potrà dire a quella persona: “Senti ci conosciamo pure, vogliamo dirlo adesso che è finito il processo? Perché non posso salutarti in questa maniera, ti incontro e mi sento male”. Capisci che il potere del dialogo diretto è diverso da quello della terapia. Il dialogo diretto, facilitato affinché nessuna delle parti si faccia del male, può avere un grande potere curativo.
Il processo penale, l’esecuzione detentiva includono molte altre vittime…le producono. Persino chi ha generato il danno può sentirsi vittima, per le conseguenze che deve pagare (il carcere, per esempio, e ben conosciamo la condizione lesiva della dignità umana che molte persone sono costrette a vivere in carcere). Ma pensiamo anche alle ricadute sui figli, la famiglia, perché è chiaro che da quel momento in poi si sentono, e forse sono, tutte vittime… penso a come stanno i miei figli, penso… il primo pensiero che viene, non lo so ai ragazzini, lo stigma, è una cosa terribile, come posso, come riesco a mettermi nei panni anche o soltanto prevalentemente della persona che ho danneggiato? Ricordo le riflessioni di Massimo Pavarini sulla vulnerabilità: nel momento del reato la persona vulnerabile è la vittima, nel processo lo diventa l'imputato, nel momento della condanna è la persona condannata. Il luogo “sicuro” della giustizia riparativa è un contesto dove le persone si incontrano per affrontare qualcosa di molto difficile, ma è proprio dall’incontro di verità che si può pensare alla riparazione possibile.
Parlando della differenza tra effetti trasformativi ed effetti terapeutici, e della raccomandazione di massimo grado a non confondere le due cose, nel suo libro c’è un accostamento con la psicologia positiva… quindi riconducendolo alla psicologia positiva, per cui invece di concentrarsi sui disturbi che possono affliggere l’uomo ci si vuole concentrare sulle potenzialità, su ciò che è positivo, e riconducendolo al contesto di comunità, intendiamo che la restorative justice è pienamente riparativa quando ci sono tutti, il dialogo è tra tutti, nella comunità ...
Riconducendolo alla psicologia positiva mi vengono in mente due aspetti, il senso di auto-efficacia e quello di efficacia collettiva. Intanto la giustizia dovrebbe essere più vicina ai componenti della comunità. La giustizia è prevalentemente vissuta lontana, non sempre accessibile e comprensibile. Nella giustizia riparativa, la comunità ha la possibilità di parlare, di chiedere e anche di rassicurarsi. Altrimenti chi ha commesso quel reato nella mia mente è sempre una minaccia, e non sono tranquilla nemmeno se è in carcere perché penso che potrebbe avere degli amici in giro, e comunque prima o poi uscirà, quindi, il mio senso di sicurezza è sempre molto relativo, basso direi… Le stesse persone che sentiamo dire “sono tutti delinquenti, questi adolescenti vanno in giro, rubano per comprarsi la droga, rubano la borsetta etc.”, se si dedica tempo per spiegare, fare in modo che possano conoscere, poter avere l'esperienza, conoscere la storia di quell'autore, di quell’adolescente. Facciamo un ragionamento pensando, ad esempio, al lavoro di pubblica utilità, che è pur sempre una pena comminata da un giudice. La persona svolge un lavoro di pubblica utilità, ma lo fa perché si tratta di una condanna, la comunità nulla sa che si tratta di una misura penale, magari immagina che è stato liberato prima e che ha anche un lavoro, e magari pensa che quel giovane sia lì per predare… non è così perché è un lavoro di pubblica utilità. Pensa come sarebbe diverso se quella misura, invece di essere stata decisa da un giudice, fosse, sia pure emessa dal giudice, ma il risultato di un incontro con la comunità… allora forse le persone sarebbero anche più tranquille di vedere nelle strade del proprio quartiere delle persone che stanno facendo un lavoro per la comunità, come una sorta di restituzione. Questo potrebbe essere un esempio in grado di restituire senso di efficacia alla persona che si è confrontata con un bisogno della comunità, e, alla comunità, senso di efficacia-collettiva quale convinzione di riuscire a raggiungere con successo un obiettivo (re-inserimento attivo, restituzione) grazie al contributo di tutte le parti coinvolte.
Oltre alla psicologia positiva, una ricaduta importante della metodologia riparativa è l’empowerment, il restituire un senso di “potere” alla vittima. E perché no, anche all’offender, che magari si sentiva solo pedina di un gioco più grande di lui, dove erano altri a dare le carte e stabilire i ruoli, e scopre di avere dei margini di libertà…
Anche in termini di autoefficacia, abbiamo citato il senso di autoefficacia e di controllo, ma non controllo nel senso negativo del termine. Io, vittima, posso incidere perché questo autore non ricommetta il crimine, perché io sto collaborando rispetto al suo cambiamento e io mi sento anche più efficace e più attivo come cittadino, come cittadina. Un vantaggio psicologico per la vittima, sicuramente, che esce dalla condizione di totale passività. Il coraggio (altro costrutto della psicologia positiva): molte vittime preferiscono definirsi sopravvissute, proprio perché hanno ripreso potere sulla propria vita, hanno avuto coraggio di affrontare chi le ha danneggiate, di chiedere, dire, “pretendere” risposte, ne ricavano un senso di efficacia personale e di coraggio.
Se è importante l’empowerment della vittima, qualcosa di simile è bene che avvenga anche per l’autore del reato. In fin dei conti, subire una condanna è una cosa semplicemente passiva, la si subisce, appunto. E l’autore finisce per sentirsi deresponsabilizzato, il che è particolarmente grave visto che già prima che la vicenda iniziasse non aveva agito con responsabilità rispetto alle conseguenze della propria azione nei confronti dei suoi “pari”, della comunità. Consentirgli/le di affermare “io ho fatto questo”, lo riporta nel ruolo di “giocatore attivo”, capisce di essere stato lui/lei a fare delle scelte, non sono state scelte di altri, del “sistema” che lo/la punisce. Per fare questo, per “rivendicare i propri atti”, anche l’autore del reato ha bisogno di coraggio. Ma, in carcere, ogni responsabilità gli/le viene praticamente negata perché “non ha diritto” alla presa di decisione. Può, di certo, confrontarsi con il personale che il sistema penitenziario delega al “trattamento”. Poche persone, ben preparate, ma sottorganico, non certo in grado di seguire tutti con l’attenzione di cui avrebbero bisogno… ma poi, soprattutto, il personale è percepito come “parte dello Stato”, quindi non neutrale, quindi qualcuno con cui devi per forza andare d’accordo altrimenti non ti fanno uscire, forse non scrivono una relazione positiva per l’accesso alle misure alternative. Nel rapporto persona detenuta-personale carcerario, anche il personale civile, quello più preparato, c’è sempre un certo livello di passività in chi sta scontando la pena. Non può decidere autonomamente cosa fare.
Il “trattamento penitenziario” è il viatico per tornare in libertà, ma è qualcosa che l’autore subisce, non sceglie. È praticamente un TSO: mi scuso per questo accostamento, ma sarebbe davvero possibile sottrarsi? Nella giustizia riparativa, invece, la vittima si sente finalmente protagonista, e anche l'autore può confrontarsi esprimendo le proprie responsabilità, ci fa un guadagno in termini di coraggio, in termini di autoefficacia, in termini di sentirsi parte attiva nel processo di cambiamento.
All’inizio la giustizia riparativa aveva una impostazione come di un processo terapeutico comunitario, una specie di grosso circolo di autoaiuto. In origine questa disciplina, 50 anni fa, dava forti aspettative, c’era molto ottimismo. Oggi nessuno direbbe più che è un “processo terapeutico comunitario”, ci possono essere effetti terapeutici sui singoli, ma anche quelli non sono espressamente ricercati, soppiantati dai più semplici “effetti trasformativi” … chi ha commesso un reato deve cambiare il suo comportamento qui e ora, il suo comportamento fattuale. Ovviamente il suo comportamento fattuale ha anche radici psicologiche, non potrebbe essere diversamente, ma non è compito del facilitatore entrare in quella fascia. Eppure, alcuni effetti “psicologici” sono acclarati: Chapman per esempio riporta uno studio britannico secondo cui l’85% delle vittime che sono state coinvolte sono soddisfatte, e la stessa statistica a cui lui fa riferimento parla di "alleviamento dei sintomi dello stress post traumatico".
Attraverso il dialogo con la comunità si ha un effetto terapeutico? Un effetto di alleviamento della sofferenza e di acquisizione del benessere e di sviluppo della persona?
Non amo i termini “terapia” e “terapeutico, in questo contesto: rischia di essere confusivo. Se usiamo il termine “terapeutico” per qualunque processo di cura e guarigione, può andare bene, altrimenti meglio non confondere: meglio, quindi, non usarlo. Ora, però, lei ha citato il trauma, e il lavoro sul trauma è un aspetto importante. Tutti i documenti internazionali prestano particolare attenzione al trauma e prevedono che intervengano professionisti formati sul disturbo da stress post traumatico. Per la verità, citando Martin Seligman (autorevole riferimento della psicologia positiva), preferirei parlare di “crescita post-traumatica”, piuttosto che di disturbo (i disturbi ci inchiodano al nostro malessere, piuttosto che orientarci a quanto può essere fatto per generare il nostro migliore Sé). La giustizia riparativa non può essere terapia. Non deve esserlo. Ma chi facilita deve avere anche delle competenze sul trauma e, a seconda dei casi, potrà essere necessario uno specifico intervento sul trauma, da parte di esperti. Poiché sto parlando a una psicologa, posso dirle che noi psicologi, forse, abbiamo una marcia in più, perché abbiamo conoscenze e competenze psicologiche, anche se in quel contesto non dobbiamo fare i terapeuti! Così come giuriste e giuristi hanno conoscenze e competenze in più rispetto al diritto, ma nel contesto della giustizia riparativa non fanno i/le giuriste. Se necessario un percorso terapeutico della vittima sul danno, sarà affidato ad altre persone, ad altri professionisti. Un terapeuta non può fare il terapeuta “dentro” un programma riparativo, se ha il ruolo di mediatore, di facilitatore, deve svolgere quel ruolo, e occuparsi solo del danno, non deve fare il terapeuta. Certo è rilevante che un mediatore/facilitatore con buone conoscenze di psicologia sia in grado di dialogare con il terapeuta che eventualmente deve seguire la vittima, l’importante è non mescolare i ruoli.
C'è qualcosa di diverso nella giustizia riparativa, qualcosa che lega in maniera indistricabile le persone, ed è il danno. Il danno lega chi ha agito o ha subito direttamente, e lega anche chi ha agito o subito indirettamente perché è parte della comunità.
La giustizia riparativa lavora sul danno derivato da un’ingiustizia che si è verificata un determinato giorno, in un determinato momento, e cerca di ripristinare giustizia, benessere e potere sulla propria vita. Partire dal danno significa riconoscere quanto avvenuto come ingiustizia e insieme lavorare per ripristinare giustizia. Affronta un giorno della vita di una persona, non la vita intera. Anche se, quanto avviene all’interno di una pratica riparativa può significare per chi partecipa toccare la propria vita, perché il danno generato quel giorno, in quel particolare momento, ci riguarda come persone, con le nostre storie, con le vicende della nostra vita. Ma ancora una volta, questo non deve far confondere un processo riparativo con un processo terapeutico. La giustizia riparativa riguarda il giusto-non giusto, e danneggiare-riparare.
Troviamo molto interessante la distinzione che lei fa tra “effetto trasformativo” ed “effetto terapeutico”. In una mediazione riparativa per come è richiesta dalla legge Cartabia, e quindi da un tribunale, si deve riparare un singolo errore del reo, non rivedere l’intera sua vita. L’incarico che viene conferito dal giudice è, comprensibilmente, limitato, ed è anche un bene che sia così perché sarebbe preoccupante se il giudice conferisse l’incarico di cambiare l’intera vita di un imputato. Rimane il fatto che la Giustizia Riparativa ha come fine ultimo, di là nel tempo, una modifica sostanziale della comunità, quindi ha, nella sua parte teorica, interesse affinché la mediazione non abbia solo effetti a breve termine sulle parti, ma anche a lungo termine. Nessuno osa definirli “cambiamenti psicologici”, ma siamo nei paraggi…
È un lavoro diverso, è un lavoro di cura. Anche se non ci fosse la comunità è diverso, anche se fosse solo autore e vittima, non stanno facendo una terapia di coppia. Perché non si conoscono? No, perché è diverso il lavoro che si fa.
Piuttosto, rispetto all’effetto trasformativo della giustizia riparativa, vorrei ricordare proprio la concezione trasformativa della restorative justice con la definizione che ne danno le Nazioni Unite[10]:
Questa è la prospettiva più ampia: non solo abbraccia processi e passaggi riparativi per riparare il danno, ma pone attenzione anche sull'ingiustizia strutturale e individuale. Rispetto alla prima, identifica e cerca di risolvere le cause sottostanti del crimine (povertà, disoccupazione ecc.). Tuttavia, sfida anche le persone ad applicare i principi della giustizia riparativa al modo in cui si relazionano con gli altri e con l’ambiente. Questo può generare una sorta di trasformazione spirituale interiore così come richiede una trasformazione sociale esterna. (p. 105) (traduzione nostra)
Come è diverso?
Perché partiamo da un presupposto diverso. Che cos'è che fa incontrare quelle due persone, autore e vittima, quelle tre persone, se vogliamo metterci anche il mediatore/facilitatore? È il l’ingiustizia, è il danno vale a dire le conseguenze di quell’ingiustizia.on sono i problemi che ha l'uno o che ha l'altro, e non è un problema come quello di una coppia che va in terapia perché come coppia devono affrontare delle cose o un gruppo, andiamo in terapia di gruppo perché è una possibilità di confronto fra persone e la terapia di gruppo amplifica anche quello che si può fare rispetto al singolo. Nella giustizia riparativa invece, intanto partiamo del presupposto, non solo che c'è il danno, ma che c'è una questione di giustizia, cioè è stata lesa qualche legittima attesa, legittima attesa che è un'attesa sociale, che, per esempio, io non esca per strada la sera e venga violentata, è una mia legittima attesa.
L’effetto e l’approccio trasformativo quindi si riferiscono alla possibilità che gli individui hanno di cambiare prospettiva attraversando, partecipando ad un processo di Giustizia Riparativa e all’impegno che a sua volta questa si assume di battersi per ridurre le ingiustizie sistematiche.
Può sembrare un ossimoro che la GR dovrà continuare a “battersi”, ma la visione Restorative prende le distanze dalla violenza, senza rifiutarsi di riconoscere, e soprattutto conoscere, e validare l’esistenza del conflitto e della possibilità che danni possono essere generati/subiti.
Il cambio di prospettiva, la trasformazione da parte della comunità può e fa uso di processi psicologici, impossibile pensare ad un processo decisionale che sia immune dall’influenza psicologica sulla cognizione umana, e ciò accade nell’intimo di ogni individuo ma anche nelle comunità.
Questo perché tessiamo relazioni tra individui e tra gruppi.
Comunità in cui si dialoga e discute dei bisogni concreti di tutti, e si vuole decidere sull’amministrazione della Giustizia, non possono essere Comunità in cui non c’è spazio per i bisogni psicologici. D’altronde, e qui cito James Bell, se le persone per cui stai prendendo decisioni non sono coinvolte nel processo di decisionale, stai facendo scelte povere. Imporre un trattamento si chiama TSO.
Dominio, potere. Deprivi le persone di quello che è uno degli aspetti valoriali fondamentali della giustizia riparativa, che è appunto l'empowerment, vale a dire assenza di dominio e prendere accordi in base a come il processo si svolge, a partire dalla propria prospettiva narrativa e grazie a quella trasformativa che emerge dalla narrazione dell’altro e dal dialogo.
Parlando di narrazione, da legge c'è scritto dialogo riparativo, poi c'è scritto anche “ogni altro programma dialogico condotto da mediatore”, quindi, sostanzialmente, il mediatore è lasciato libero di scegliere il programma che ritiene più opportuno nel formato e nel momento più opportuno, se poi arriva a un esito riparativo lo può sottoporre a un magistrato che poi decide se valutarlo come attenuante, messa alla prova, richieste di condizionali, etc..
Però quelle cose le vorrei mettere da parte, nel senso che è la giustizia formale che si è appropriata della giustizia riparativa. Che quest’ultima venga utilizzata secondo la logica punitivo-premiale del sistema penale è un rischio, non possiamo non considerarlo. Che l'esito, l’accordo raggiunto, venga comunicato è fondamentale. Perché è l'accordo che hanno raggiunto le parti e deve essere per certi versi sancito, mentre ciò che è avvenuto nell’incontro non deve essere riferito al giudice. Le due parti potrebbero aver raggiunto un accordo puramente strumentale, oppure potrebbero aver sviluppato un’amicizia reale, o potrebbero aver riversato nel dialogo riparativo tutti i dolori e le speranze della loro esistenza, questo non è oggetto della comunicazione al giudice. Nulla si deve comunicare, a meno che non lo vogliano, espressamente, le parti.
Aggiungo una precisazione rispetto al tipo di programma di giustizia riparativa. Chi media o facilita (io preferisco il termine facilitatore, peraltro indicato nella Raccomandazione europea del 2018) sceglie in base alle caratteristiche del caso, della situazione. Sceglie cioè in base a ciò che è più adatto per quella situazione.
Vorrei concludere con una breve citazione di John Braithwaite, peraltro vincitore quest’anno del Premio Balzan per la Giustizia riparativa:
In questo saggio la Giustizia Riparativa è concepita come un processo in cui tutte le parti interessate da un'ingiustizia hanno l’opportunità di discutere le conseguenze dell'ingiustizia e ciò che potrebbe essere fatto per porvi rimedio. Si tratta di una concezione processuale della giustizia riparativa, in cui ciò che deve essere ripristinato è lasciato aperto. Piuttosto, le forme di ripristino delle vittime, degli autori di reato e delle comunità che contano sono quelle ritenute importanti in un tale processo di giustizia riparativa. Oltre alla concezione del processo, esiste anche una concezione valoriale della giustizia riparativa. Il valore chiave è che, poiché l'ingiustizia fa male, la giustizia dovrebbe guarire. Rispondere al dolore con "un'altra cucchiaiata di dolore" è vista come una risposta meno soddisfacente che rispondere con la guarigione o la riparazione. Il motivo è che il dolore tende a generare dolore, creando una spirale viziosa di punizioni e faide. In alternativa, è possibile trasformare questa dinamica in una dinamica di guarigione che genera guarigione - un circolo virtuoso[11].
E in sostanza questo è la Giustizia Riparativa: una parte “formale”, e la speranza che raggiunto l’accordo formale si sviluppi anche qualcosa di sostanziale, il tutto all’interno di una cornice di l’ascolto delle volontà delle parti… Grazie Professoressa
(a cura di Arianna Fioravanti)
[1] L’European Forum for Restorative Justice (in breve EFRJ o Euforum) è “un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro con sede presso l'Università di Lovanio (Belgio), fondata nel 2000, in assoluto il primo think-thank riparativo in Europa, e ancora oggi il più ramificato e importante. È composto da più di 500 membri in Europa e oltre, tra cui più di 90 organizzazioni, che si dedicano alla ricerca, alla pratica e alle politiche di giustizia riparativa, principalmente in contesti di giustizia penale, ma anche nelle scuole, nelle comunità, nelle famiglie e nella costruzione della pace.”
[2] Carocci Editore, 2024
[3] La Legge Cartabia, e le norme attuative approvate in seguito, comprese alcune modifiche alla legge nella sua prima versione dell’ottobre 2022.
[4] Uno dei passaggi amministrativo-burocratici previsti dalla Legge Cartabia per l’implementazione della legge.
[5] Uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) rappresentano un’articolazione del Ministero della Giustizia e sono deputati alla presa in carico delle persone sottoposte a misure esterne all’Istituto penale. Centrale all’interno degli UEPE è la figura dell’assistente sociale, che ha l’incarico di supervisionare l’andamento delle varie misure alternative che un giudice può aver deciso nei confronti di un condannato, dalla messa alla prova, all’assegnazione ai lavori socialmente utili eccetera.
[6] Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.
[7] Livelli Essenziali delle Prestazioni: lo standard fissato dalla Legge Cartabia perché gli enti (società, o cooperative, o associazioni) che già da tempo lavoravano nell’ambito della Mediazione Penale, o enti di nuova costituzione, possano chiedere l’accreditamento presso il Ministero della Giustizia, e diventare ufficialmente fornitori del servizio “Giustizia Riparativa” al Ministero stesso.
[8] Uno dei passaggi amministrativo-burocratici previsti dalla Legge Cartabia per l’implementazione della legge.
[9] Alta Sicurezza 3: il livello più restrittivo del sistema penitenziario italiano. ospita detenuti per reati di associazione di stampo mafioso, vertici del narcotraffico, sequestratori di persona e simili.
[10] UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice Programmes (2006), pag. 104 (traduzione nostra) https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
[11] The Fundamentals of Restorative Justice, 2003. (traduzione nostra)