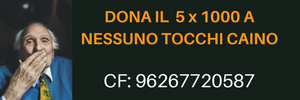31 Dicembre 2023 :
Francesco Petrelli* su L’Unità del 31 dicembre 2023
Per me è una grande emozione essere qui, anche perché è la prima volta, in occasione del vostro Congresso, che entro nel Teatro del carcere di Opera. Anche se la frequentazione degli istituti carcerari, per chi fa di professione l’avvocato penalista, è comunque un’esperienza dolorosa, devo dire che coloro che si occupano assiduamente di carcere fanno un’esperienza diversa, perché testimoniano di quella speciale sofferenza che è la sofferenza inflitta da un uomo a un altro uomo. Una sofferenza inflitta “a fin di bene” diversa da tutte le altre sofferenze che, al contrario, l’uomo patisce per malattia, per calamità, o anche per crudeltà, per la natura belluina dei suoi simili. Chi conosce e sperimenta questa particolare forma di sofferenza inflitta dall’uomo sull’uomo a fini di giustizia, sa che, per quanto noi possiamo dirla necessaria, si tratta di una sofferenza terribile.
E sa che terribile è la responsabilità di chi la infligge.
Chi fa il nostro lavoro di avvocati, chi frequenta il carcere da operatore conosce quella sofferenza e sa di doverla spiegare alla collettività nella quale vive. Ma non è facile trasferire quel senso di frustrazione e di impotenza che la pena in questa forma e in questi luoghi inevitabilmente produce.
L’idea di una giustizia applicata in una forma irrimediabilmente ingiusta diviene allora ancor più insopportabile per il numero delle privazioni e dei disagi fisici e morali. A partire dalla terribile realtà del sovraffollamento, dell’insufficienza delle risorse, della mancanza tanto degli operatori che delle figure dirigenziali, del personale amministrativo e di quello della polizia penitenziaria. Anche l’ordinamento penitenziario è insufficiente, reduce di quella riforma mutilata degli Stati Generali dell’esecuzione penale. Insufficiente è la sorveglianza sotto il profilo strutturale della mancanza di un reale contraddittorio e di una effettiva progettualità nella formazione dei percorsi alternativi. Senza dimenticare le carenze della sanità, dell’igiene, dell’assistenza psichiatrica dell’affettività obliterata, a fronte di una popolazione afflitta dal disagio e dalle dipendenze. Per non dire di quella atroce conta dei suicidi che il carcere colpevolmente produce o altrettanto colpevolmente non è in grado di evitare.
Il principio contenuto nell’articolo 27 della Costituzione, che sancisce la finalità rieducativa della pena, ha cominciato da tempo ad essere percepito dalla collettività come un principio in qualche misura antistorico, frutto di un “buonismo” fuori luogo. Ci si chiede come sia possibile pensare che, in una società assediata dal crimine, la pena non debba avere un contenuto esclusivamente afflittivo e contenitivo nei confronti del condannato. Ma si dimentica che gli anni in cui fu scritto quell’articolo erano quelli terribili della fine del conflitto mondiale, nei quali si era appena usciti da una terribile guerra civile. Anni nei quali il conflitto aveva lasciato nel Paese una enorme disponibilità di armi, con una criminalità resa più brutale dai tempi della guerra. Le rivolte nel carcere in quel periodo erano all’ordine del giorno. Eppure in un simile contesto i nostri padri costituenti scrissero quelle parole, cogliendo quell’unica ragione giustificatrice che può avere una pena inflitta da un uomo a un altro uomo, che non può che essere quello del fine della risocializzazione.
Io ringrazio gli amici e compagni di viaggio di Nessuno tocchi Caino, per essere stati i nostri giovani maestri della difesa degli ultimi; abbiamo marciato insieme per l’amnistia e per l’indulto, parole che oggi suonano come un’eresia e che dovrebbero invece, in questa situazione drammatica, tornare a circolare.
È vero che in questo contesto, nel quale c’è nel Paese un evidente impoverimento della cultura dei diritti e delle garanzie, è difficile recuperare i valori dei nostri padri costituenti, quelle prospettive ideali. Se noi dovessimo tuttavia immaginare che questi valori e questa nostra cultura sono destinati a rimanere inevitabilmente minoritari, saremmo in errore. Perché una cultura minoritaria può dirsi minoritaria se può vantarsi di essere una vera cultura, se ha in sé un fondamento autentico di verità. E, se così è, quella verità non può che essere comunque al fondo della coscienza di ciascuno di noi. E attende solo di essere con fatica portata alla luce e riconosciuta come un valore condiviso. Se questo è vero, è allora compito di tutti noi cercare in fondo alla coscienza della nostra collettività spaventata e disorientata quel principio secondo il quale l’essere umano non può essere mai trattato come un mezzo. Come scriveva Beccaria, la legge non deve trattare mai l’uomo come una cosa, perché sarebbe la fine della libertà di tutti noi. E allora, se così è, culture minoritarie destinate a rimanere tali non possono esistere se non per una nostra responsabilità e per la nostra inerzia, perché vuol dire che non siamo stati capaci di cercare ciò che era nostro dovere trovare.
* Presidente UCPI, sintesi dell’intervento al Congresso di Nessuno tocchi Caino